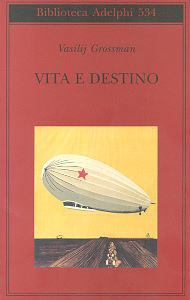 “A me l’ironia fa male. Anzi, la odio. (…) Perché ce n’è sempre di più, troppa, la nuova ironia italiana che brilla su tutti i musi, in tutte le frasi, che ogni giorno lotta contro l’ideologia, le divora la testa, e in pochi anni dell’ideologia non resterà più niente, l’ironia sarà la nostra unica risorsa e la nostra sconfitta, la nostra camicia di forza, e staremo tutti nella stessa accordatura ironico-cinica, nel disincanto, prevedendo perfettamente le modalità di innesco della battuta, la tempistica migliore, lo smorzamento improvviso che lascia declinare l’allusione, sempre partecipi e assenti, acutissimi e corrotti: rassegnati.
“A me l’ironia fa male. Anzi, la odio. (…) Perché ce n’è sempre di più, troppa, la nuova ironia italiana che brilla su tutti i musi, in tutte le frasi, che ogni giorno lotta contro l’ideologia, le divora la testa, e in pochi anni dell’ideologia non resterà più niente, l’ironia sarà la nostra unica risorsa e la nostra sconfitta, la nostra camicia di forza, e staremo tutti nella stessa accordatura ironico-cinica, nel disincanto, prevedendo perfettamente le modalità di innesco della battuta, la tempistica migliore, lo smorzamento improvviso che lascia declinare l’allusione, sempre partecipi e assenti, acutissimi e corrotti: rassegnati.
(…) Tra l’ironia e il ridicolo, scelgo il ridicolo.” (G.Vasta, “Il tempo materiale”)
“Preferisco il ridicolo di scrivere poesie, al ridicolo di non scriverne.”
W. Szymborska, “Possibilità”)
La steppa calmucca è compresa in una vasta area distesa a Oriente, una landa che sconfina in deserti sabbiosi, stemperata fino alla Siberia e abitata principalmente e originariamente da popoli nomadi di fede buddista.
È in questo scenario immenso di spinose erbe e cammelli, da noi occidentali forse appena immaginabile, che si svolge un piccolo, forse insignificante, episodio di quel capolavoro che è “Vita e destino” di Vasilij Grossman. Siamo durante la seconda guerra mondiale; un tenente colonnello viene inviato dallo Stato Maggiore dell’artiglieria sovietica a verificare lo stato delle truppe all’”estrema sinistra del fronte”. Lo incontriamo qui, mentre attraversa la steppa su un’automobile, diretto al quartiere generale dell’esercito.
Il tenente colonnello arriverà al quartiere, sbrigherà le poche pratiche che ha in consegna, giocherà a briscola con alcuni militari, tra cui una donna con la quale, Grossman lascia intendere, avverrà un incontro d’amore quella stessa notte. Dialoghi militari, scambi di battute da soldati, sottintesi erotici: la permanenza del tenente colonnello al quartiere è breve e prosaica. Nel giro di qualche pagina l’episodio è concluso.
Ma c’è qualcosa di estremamente rilevante, anche a livello formale, che avviene in questo breve lasso: durante l’attraversamento della steppa il tenente (e il lettore con lui) ha una sorta di epifania. E questa epifania, questa scoperta improvvisa che non è in alcun modo razionale o esplicita, avviene attraverso una descrizione intrisa di lirismo.
Il romanziere che è riuscito a raccogliere il Novecento in un’architettura narrativa che sfora le ottocento pagine si scioglie quasi in una prosa poetica quando vuole parlare di ciò che così tanto gli preme, ovvero la libertà.
Appare evidente che questo non sia un caso e che meriti attenzione. Perché scegliere il lirico quale nota dominante nella descrizione di un ambiente naturale eletto a simbolo di uno stato umano che è al contempo concetto, meta, percezione, pomo della discordia e – ad oggi – parola abusata e violentata, è un segno molto forte. È il restituire alla poesia la centralità che l’accolita umana le ha infine sottratto, riducendo la parola più verticale che siamo in grado di concepire e intendere a semplice genere minore, a occasione di triviali querelle tra addetti, a remoto immaginario depotenziato di gobbi e sognatori.
Non è questo della steppa un episodio isolato nel libro: i momenti cruciali sono spesso consegnati o sottolineati da versi che i protagonisti recitano a memoria o leggono ai loro compagni (come avviene ad esempio sotto i bombardamenti tedeschi nel versante russo del fronte sul Volga, in cui un “lurido e arruffato” soldato legge Puškin ai compagni).
Grossman con questa sorta di espediente – che a onor del vero non risulta affatto quale semplice “trucco”, ma anzi si presenta come momento perfettamente organico all’interno del romanzo – pare indicarci una posizione precisa in merito al ruolo della parola poetica, alla sua potenza deflagrante e alla sua contemporanea fragilità in quanto materia che si sottrae all’utile imperialisticamente inteso.
Se questo sentiero ci è stato indicato nel Novecento, pure è stato interrotto o non seguito negli anni a venire, e questo sembrerebbe vero per molte delle discipline artistiche in cui l’Occidente si cimenta.
Non sbaglia Scarpellini nella sua lettera “Contro il pop” quando riflette sul fatto che il pop e in generale il postmoderno non sono in grado di accogliere la poesia e “l’orizzonte aperto dalla sua alterità”. Tutti i dispositivi ironico-cinici che vengono attivati nella gran parte degli spettacoli teatrali degli ultimi anni, ad esempio, non sono che il riflesso di quella generale tendenza a rifiutare il mistero che noi restiamo a noi stessi, e al contempo i molti misteri che dobbiamo affrontare: la morte, i legami, la spietata bellezza della natura, il nostro dissiparci, la vita stessa.
Chiaramente tutto questo è perturbante e doloroso nella sua inconoscibilità e forse potersi concentrare sui meccanismi della comunicazione o su qualunque altro elemento che possa essere governato e reso impermeabile è un modo di rassicurarci.
L’ironia stessa è qualcosa di rassicurante, in quanto immobilizza e neutralizza qualunque termine che con essa si confronti.
La poesia, al contrario, non rinuncia mai al suo elemento destabilizzante, non si lascia imbrigliare. Restano fallimentari, ad avviso di chi scrive, gli esempi di quei versi che hanno tentato di uscire dal loro nascondiglio per andarsi a confondere con sistemi di pensiero rigidi, formali ideologie, generiche avanguardie, dismettendo la loro anarchia in nome di una qualche riconoscibilità.
Con ciò non si vuole significare che la poesia sia incapace di reggere i più alti esiti del pensiero, tutt’altro: quando anzi resta confinata nel semplice o vago “poetico” o nell’intimismo fine a se stesso non è che una pallida ombra, quella di cui abbiamo più o meno tutti alcune memorie scolastiche.
Ma, a quanto è dato vedere, c’è in Italia oggi un nutrito numero di opere di poesia che – forse più che nel teatro e nella narrativa – hanno il coraggio di affrontare la più pregnante delle materie, il più difficile dei temi – l’uomo – e lo fanno senza concedere sconti e senza soffermarsi in accattivanti piaggerie. Forse è per questo che la poesia non ha mercato? Perché non sa fare nessuna ironia sul nostro tempo? Lo stesso distacco di cui a volte si ammanta il premio Nobel citato in apertura, ha infatti un altro nome, che si mescola all’impegno e alla profondità in una strana miscela. E questo nome sembrerebbe, a ben vedere, leggerezza. La stessa, mobile, segreta qualità che fonde terra e cielo nelle lande vibratili della steppa.
Azzurra D’Agostino
Leggi anche:
Epica, Etica e Pop – manovre di uscita dalla post-modernità tra letteratura e teatro. di Graziano Graziani
CONTRO IL POP (Prima lettera critica) di Attilio Scarpellini













“Chiaramente tutto questo è perturbante e doloroso nella sua inconoscibilità e forse potersi concentrare sui meccanismi della comunicazione o su qualunque altro elemento che possa essere governato e reso impermeabile è un modo di rassicurarci.
L’ironia stessa è qualcosa di rassicurante, in quanto immobilizza e neutralizza qualunque termine che con essa si confronti.”
Ed è davvero “ironico” (o forse ridicolo) leggere, oggi, di un’ironia “rassicurante”, pensando a Rabelais a Brecht a Wilde a Kraus e a tutti gli altri che, demistificando, hanno pagato con pire accese non solo metaforicamente. Eppure mi trovo del tutto d’accordo con quanto scrive la D’Agostino: come quasi sempre succede, l’ipertrofia di un meccanismo -per quanto corrosivo possa essere- si rivolge in atrofia. Così l’ironia, rubando le meravigliose parole di Scarpellini, è una condizione, piuttosto che uno strumento, del post-moderno: si è svampita in disillusione, in mero nichilismo. Un nichilismo aggravato da un’assoluzione ammannita con piacere a sé stessi, perché con la legge assoluta della distanza ironica ci si sente, in fondo, estranei e un po’ più innocenti, rispetto al mondo circostante e rifiutato. Timpano e Cosentino, per esempio: artisti fenomenali, di cui ogni spettacolo mi ha arricchito, aiutato a mettere in discussione certi schemi e stereotipi. Però non ci si può fermare alla critica del linguaggio: il ‘900 ha distrutto abbastanza, non è l’ora di ricostruire? Altrimenti si rimane iconoclasti, e non (cinici) poeti… (Mi permetto di dare un giudizio così lapidario perché, ripeto, apprezzo moltissimo il loro lavoro; mi sembrano però un esempio molto calzante al discorso).
In poesia c’è un’autrice che, a mio parere, ci sta accompagnando fuori dal post-moderno a passi consapevoli e devastanti: Maria Grazia Calandrone. Rivaluta il pathos animando il peso del corpo, della materia, con la leggerezza della sua infinita e impossibile scoperta: a me fa pensare, per continuare a tessere il ponte fra teatro e poesia, ai Santasangre. E’ proprio dall’incrocio tra orizzontalità e verticalità, fra teatro della materia e poesia dell’ancora autentico, che forse si riuscirà ad uscire, finalmente, dal post-moderno…
Molto bello questo articolo, eppure non riesco a ritrovarmi in un approccio tanto manicheo. Da una parte il “pop” e i dispositivi ironici, dall’altra la poesia e la rimozione del drammatico. Sicuramente banalizzo, ma penso che siamo ancora tutti in grado di distinguere un’ironia bella da una brutta, un’ironia sorprendente e che arricchisce da un’altra banale, fritta e rifritta. Casualmente, proprio ieri rivedevo un classico del nostro teatro, Natale in Casa Cupiello. La fine del secondo atto realizza per me contemporaneamente il massimo del drammatico e il massimo del comico (quest’ultimo nella forma del distacco ironico), e le due cose traggono forza l’una dall’altra. Ecco, qui, nel viso di Pupella Maggio che non sa se piangere o ridere, intravedo la forma poetica “destabilizzante”, e forse dovremmo pensare di più a Eduardo che a Warhol o a Ravenhill. In fin dei conti questa discussione iniziata con l’articolo di Graziani riguarda l’Italia e si dovrebbe sempre considerare la peculiarità di questo nostro strano Paese, patria del melodramma (non del dramma), dove la forma mentis melodrammatica intacca avidamente l’ideologia, la politica, la religione, le forme sociali, l’arte. L’ironia in Italia, quindi, almeno quella “buona”, è l’ultima difesa che ci resta per resistere ad un processo di “beotizzazione” collettiva. L’ironia è distacco, sì, ma distacco dal nemico, non dalla partecipazione. L’ironia che non prende posizione – e non la prende non perché il distacco sia insito nel meccanismo ironico, ma perché non è ideologicamente sostenuta – quella sì che non esprime altro che l’inconsistenza di chi ne fa uso.