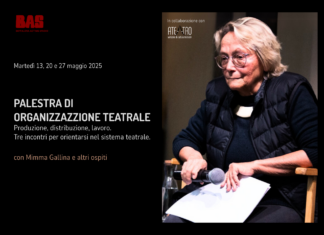Recensione. Parallax di Proton Theatre, scritto da Kata Wéber, diretto da Kornél Mundruczó e visto in prima nazionale al Piccolo Teatro di Milano

Basta scorrere la rassegna stampa degli ultimi due giorni per trovare titoli simili, ne citiamo solo alcuni: “Schiaffo di Orban alla Corte penale internazionale: riceverà Netanyahu”, o anche “Orbán calpesta l’Aja: Netanyahu ospite d’onore a Budapest” e pure “Da Macron a Merz, fino a Orbán. La vicinanza dei leader europei a Netanyahu e la sconfitta del diritto internazionale”. E sempre di “sberle” vogliamo parlare perché, per quanto riguarda l’ambito teatrale e anche cinematografico invece, la coppia Kata Wéber, drammaturga, e Kornél Mundruczó, regista, insieme alla loro compagnia ungherese Proton Theatre, continuano a dare schiaffi di senso e militanza politica ai sovranismi europei grazie alla loro, sempre imperdibile, produzione artistica. Dopo la frammentazione del reale in Pieces of a Woman (2020), il suo ribaltamento in Imitation f Life (2021) arriviamo ad oggi al multi percettivo Parallax, ultimo “manifesto” di Wéber/Mundruczó – i loro spettacoli e/o film si fondano su principi politici scolpiti, dichiarati, incontrovertibili ma non per questo reazionari o dogmatici – presentato in prima nazionale al Piccolo Teatro di Milano.

«Kata Wéber e Kornél Mundruczó, entrambi ungheresi, non avrebbero deciso di ambientare la versione teatrale di Pieces of a Woman a Varsavia se non fossero stati sensibili alle lesioni alla libertà di pensiero e azione avallate dal sovranismo di Kaczyński, in Polonia, e del primo ministro Viktor Orbán in Ungheria, senza contare le velleità salviniane che mirano a possibili accordi con entrambi i leader» così scrivevo nel passato articolo, a qualche mese di anticipo dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Oggi, a distanza di quattro anni, con i nuovi equilibri geopolitici che affermano il fallimento delle democrazie in Occidente, con il ReArm Europe Plan da 800 miliardi che viene stilato proprio nell’ottantesimo anno dalla fine del secondo conflitto mondiale, con le indecenti e omicide (in)azioni nei confronti delle rotte migratorie, vedere uno spettacolo come Parallax in Italia è quanto di più teatralmente desiderabile. Creare, programmare e interrogarsi attorno simili progetti in questo periodo storico, significa difenderli e riconoscerne la loro doverosa esistenza, come presidi di pensiero contro il nichilismo imperante.

Parallax è il prosieguo teatrale di Quel giorno tu sarai, traduzione italiana del titolo originale Evolution, un film del 2021 diretto sempre da Kornél Mundruczó per la sceneggiatura di Kata Wéber che parla di tre generazioni di una famiglia di ebrei ungheresi, dalla Budapest del 1945 alla Berlino dei giorni nostri (stessa successione cronologica e origine dei protagonisti del film candidato agli Oscar The Brutalist per la regia di Brady Corbet). In Parallax, le tre generazioni sono rappresentate rispettivamente, e in ordine di apparizione, dalla nonna Eva (Lili Monori, celebre attrice ungherese già protagonista di Evolution), sua figlia Lena (Emőke Kiss-Végh) e il figlio, nonché nipote di Eva, Jónás (Erik Major). Subito si potrebbe pensare: ancora con la questione ebraica? Proprio ora, quando il genocidio del popolo palestinese da parte del governo israeliano sta giungendo a un’efferatezza sempre più criminale e indefessa? Sì, proprio ora e proprio la questione ebraica. E c’è una ragione. Prendendo in prestito le parole dell’antropologo Marco Aime, intervenuto durante l’incontro Individui, culture e identità. Un viaggio tra cinema e teatro nell’opera di Kornél Mundruczó, «la retorica identitarista guarda al passato con la metafora usata delle radici, come se fossimo delle piante, in realtà la storia dell’umanità è fatta coi piedi, è fatta di movimento, di incroci e di scambi. L’identità è qualcosa che accade domani, è come noi la costruiamo tutti i giorni con le relazioni che intratteniamo, con l’altro, con l’ambiente. L’identità ci dà l’idea della purezza ma in realtà siamo il prodotto di un meticciato». La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel 2020, affermava in un’intervista, a proposito della canzone Imagine di Johnn Lennon, «È l’inno dell’omologazione mondialista, io francamente sto da un’altra parte. L’identità è un valore, tutto quello che abbiamo, che siamo. Credo nell’identità delle nazioni, dell’identità religiosa, dell’identità familiare». La Shoah rappresenta il “peccato originale” per l’Europa e per una parte del mondo; la catastrofe in nome dell’identità, e su questa colpa si poggia l’indicibile sostegno della comunità internazionale occidentale all’occupazione e sterminio di Gaza, ed è consequenziale che la compagnia Proton Theatre decida di partire da questa irrisolta e sanguinosa questione identitaria, che continua a mietere vittime, osservandola attraverso il fenomeno visivo del parallax: un oggetto, in questo caso l’identità, cambia a seconda di come e da dove lo si guarda. Per farlo i fatti sono inquadrati tre volte, da tre angolazioni diverse, come tre momenti formalmente separati, tanto che il linguaggio scenico sfugge all’organicità della scrittura teatrale e si segmenta in quella cinematografica. Anche riguardo gli effetti speciali che non sveleremo.

In scena è allestita una scatola/casa in cui si alternano i tre momenti. Nel primo, entriamo in contatto con le protagoniste innanzitutto attraverso il video, proiettato su due schermi che chiudono la casa ai lati, su di essi, lunghe inquadrature di primo piano inquadrano il volto di Eva, signora anziana ungherese, in vestaglia, capelli scapigliati, probabilmente malata di demenza senile, mezza addormentata in un passato doloroso ma svegliata da un presente che glielo ricorda e al quale si oppone: si rifiuta di ritirare, forse l’ennesima, medaglia d’onore in quanto sopravvissuta all’Olocausto. Sempre sugli schermi sui quali campeggiano anche i sottotitoli in italiano e in inglese, difficili da seguire onestamente — è infatti curioso notare quanto il profluvio delle parole in lingua originale, in ungherese, sia più lungo di quanto poi venga tradotto — la vediamo prendere appunti convulsamente sul taccuino, fissare lo sguardo nel vuoto, toccarsi i capelli e inveire contro il peso di questa identità ebraica che la definisce e limita in un’univoca rappresentazione di sé. Quella definizione che però serve alla figlia Lena, che incalza la madre dopo essere entrata nella casa della donna anziana con irruenza perché invece lei, da madre single e giovane, avrebbe proprio bisogno di una certificazione che attesti la sua identità per poter iscrivere il figlio a scuola. I due schermi allora scivolano ai lati e lasciano aperta la visione sulla casa, la varietà accumulata degli oggetti e i corpi delle attrici dal video diventano quindi visibili e tangibili sulla scena, li vediamo per come sono, in tutta la loro fisiologica umanità: alla fine, la madre sta per vestirsi per andare a ritirare la medaglia ma non si trattiene e un filo di urina le scorre sulle gambe.

Nel secondo fatto, sono passati degli anni, la nonna è morta e il nipote Jónás, che vive a Berlino, torna in quella casa il giorno prima del funerale. La madre non c’è e quindi decide di organizzare un’orgia omosex con tanto di droga e sex toys invitando alcune persone rintracciate tramite un’app di incontri. Nell’attesa, diegeticamente, parte il brano Soldi di Mahmood che il ragazzo ascolta in cuffia. La scena del festino hard è decisamente pornografica e molto lunga per dare al restante cast (Roland Rába, Sándor Zsótér, Csaba Molnár, Soma Boronkay) il tempo necessario di strutturare una drammaturgia scenica improvvisata, come specificato anche nei crediti, che si equilibri in solitudine, sensualità, violenza, incertezza e che, dall’aspetto meramente fisico e carnale, si sposti sul piano intellettivo e ideologico. Proprio in questa parte centrale emerge l’eredità identitaria affrontata nella prima, gli effetti attuali non tanto dell’essere ebreo per Jónás, “etichetta” alla quale lui non fa neanche riferimento nei dialoghi post festino, quanto di incorporare un altro stigma, quello dell’omosessuale, che infatti non vive più a Budapest ed è emigrato nell’inclusiva Berlino. A tal proposito si recuperino anche i recenti articoli riguardanti ciò che l’Europa intende fare dopo che in Ungheria è stata approvata la nuova legge che vieta la marcia del Pride da parte delle comunità LGBTQ+ e impone multe agli organizzatori e alle persone che partecipano all’evento che Budapest organizza da ormai tre decenni. Tornando alla scena, per la quale in un clima simile ci auguriamo non ci siano provvedimenti repressivi da parte di Orbán, il dissidio identitario divampa in tutta la sua repressione soprattutto quando a parlare, con rabbia, sono il professore sposato con moglie e figli e l’esponente politico di destra, nudi come vermi che cercano, invano, di difendersi con tesi mistificatorie, le stesse di cui sono pieni i programmi politici di destra. La lite si spegne, gli invitati lasciano la casa, Jónás resta solo.

Il terzo fatto, quasi una sintesi dei primi due è ambientato l’indomani, il giorno del funerale della nonna Eva, quando Lena entra nella casa e trova il figlio addormentato e coperto con la vestaglia che fu della nonna. Un simbolo/oltraggio molto funzionale che in un raccordo del tutto inconscio, e poco filologico forse, fa pensare al giovane Lou Castel ne I pugni in tasca di Bellocchio quando ride sguaiatamente vicino al catafalco della madre uccisa. Dopo essere stato bruscamente svegliato dalla madre, a suon di vibratori fallici, il figlio intrattiene con Lena un dialogo profondo, onesto, pieno di risentimento e paura e volontà di autodeterminazione, a prescindere dalle “radici”. Il dialogo e abbraccio madre/figlio è la ricostituzione filiale di un’armonia? C’è quindi una pace identitaria? Non lo sappiamo, ma a chiudere uno spettacolo sull’identità sono una giovane donna e suo figlio omosessuale. E infine godiamo catarticamente della danza conclusiva, forse una risposta alle nostre domande che riporta l’intero eccellente, naturalistico e empatico cast sul palco. Una danza sognante, utopistica, liberatoria, fatta di sorrisi e sguardi; una danza consapevole, i cui corpi che ondeggiano conservano la memoria di quanto detto e vissuto finora. Sembra perciò ricordare quella danza felliniana e eterea di 8 1/2 ma anche quella più cupa e bergmaniana de Il settimo sigillo, di certo è un finale estatico, più della precedente orgia. All’identità come concetto singolare, censorio, fissativo e fascista, Wéber/Mundruczó fanno corrispondere la speranza costruttiva di un futuro fatto di tante identità, plurali, inclusive, indefinite, mutevoli per il quale ci chiediamo, esisterà ancora un’Unione capace di attuarlo e tutelarlo?
Lucia Medri
visto al Piccolo Teatro di Milano – marzo 2025
PARALLAX
testo scritto da Kata Wéber, comprendendo anche le improvvisazioni della compagnia
regia Kornél Mundruczó
con Lili Monori, Emőke Kiss-Végh, Erik Major, Roland Rába, Sándor Zsótér, Csaba Molnár, Soma Boronkay
scene Monika Pormale
costumi Melinda Domán
luci András Éltető
collaborazione artistica e producer Dóra Büki
dramaturg Soma Boronkay, Stefanie Carp
musica Asher Goldschmidt
coreografia Csaba Molnár
produzione Proton Theatre in coproduzione con Wiener Festwochen | Freie Republik Wien, Odéon-Théâtre de l’Europe, Comédie de Genève, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, HAU Hebbel am Ufer, Athens Epidaurus Festival, Festival d’Automne à Paris, Maillon Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, International Summer Festival Kampnagel – Hamburg, CNDO Orléans, La Bâtie – Festival de Genève
con il supporto di Gábor Bojár e dott.ssa Zsuzsanna Zanker, 220volt, Számlázz.hu, Minorities Talents & Casting, Danubius Hotels