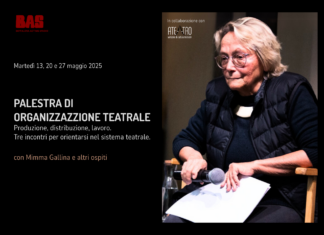Luca Lòtano, responsabile progetti teatrali di Asinitas e dottorando presso l’Università degli Studi di Palermo, in conversazione con Serena Cinquegrana, direttrice dell’Istituto italiano di cultura a Dakar. Un’intervista che è anche uno sguardo sulla scena performativa senegalese e sulle relazioni culturali con i progetti italiani.
Domenica 9 marzo sono al MAXXI di Roma per l’ultimo giorno dell’installazione Juroom ñaar di Binta Diaw, artista italo-senegalese nata a Milano nel 1995, finalista del MAXXI BVLGARI PRIZE. Sono nella penombra della scultura composta da sette colonne in memoria delle donne del villaggio senegalese di Nder che per fuggire all’attacco dei guerrieri Mauri, e evitare la conseguente schiavitù, si immolarono bruciandosi vive mascherate da uomini nel 1819. Nello spazio espositivo, attorno alle sette sculture di carbone e trecce di capelli che commemorano i corpi delle donne, si annodano voci e suoni in lingua wolof “rappresentativi della tradizione orale dei cantastorie locali (griots)”.
Sono davanti all’opera di Binta Diaw perché qualche settimana fa in Senegal, dove mi trovavo per il Dottorato di ricerca in Migrazioni Differenze e Giustizia Sociale dell’Università di Palermo, partecipavo nell’Istituto italiano di cultura all’evento “Souvenir d’Italie” con la mostra presentata in occasione della XV edizione della Biennale d’arte di Dakar ( https://biennaledakar.org/ ) – sezione OFF e della XIII edizione di Partcours ( https://partcours.art/ ). Al suo interno avevo conosciuto l’opera di tre artisti che lavorano tra l’Italia e il continente africano: Binta Diaw, Aji Dieye nata a Milano nel 1991 e a lavoro tra Milano e Dakar, e Délio Jasse artista nato a in Angola e attualmente a Milano.
All’uscita dal MAXXI riprendo in mano gli appunti di quelle intense giornate passate a Dakar: rafforzare il dialogo tra il sistema dell’arte contemporanea italiana e senegalese era al centro dei panel della due giorni di incontri organizzata dall’Istituto italiano di cultura, un Souvenir d’Italie per superare cliché e luoghi comuni, sovvertire lo stereotipo implicito da cartolina di una supposta italianità, provando a ripensare alle identità in un contesto artistico globale, tra diaspora e modelli multiculturali. Sono contento di continuare a trovare tracce di quel filo anche tornato qui a Roma, al MAXXI; mi propongo allora di continuare a tenderlo quel filo tra Italia e Senegal, riportando traccia su queste pagine di alcuni dei rapporti culturali e artistici delle arti performative, almeno quelli che per me sono passati attraverso l’incontro con l’IIC di Dakar.
Tra le relatrici di quella giornata di incontro sulle residenze artistiche c’erano anche Fatima Bintou Rassoul SY Direttrice dei programmi RAW Material Company http://www.rawmaterialcompany.org/_RAW_home interessante centro di produzione artistica di Dakar, e Jennifer Houdrouge Fondatrice e direttrice di Selebe Yoon https://fr.selebe-yoon.com/ galleria d’arte contemporanea e luogo di residenze artistiche, nonché Massamba Mbaye Presidente della sezione OFF della Biennale di Dakar 2024 e curatore del Padiglione del Senegal alla Biennale di Venezia 2024, e Mohamed Abdallah Ly Direttore generale del Museo delle civiltà nere di Dakar inaugurato nel 2018 sotto la presidenza di Macky Sall, importante complesso costruito con un ingente finanziamento ricevuto dalla Cina che ripercorre le testimonianze artistiche delle culture del continente africano dalla preistoria al presente.
Nelle settimane successive passate in Senegal seguendo l’anteprima dello spettacolo teatrale Il paese dove non si muore mai coprodotto da Teatro delle Albe / Ravenna Teatro, Ker Theatre Mandiaye Ndiaye e Teatro Caverna, nell’ambito del progetto “Bergamo, Ravenna, Dakar andata e ritorno”, sostenuto dall’Istituto italiano di cultura e che debutterà quest’anno in Italia, ho avuto modo di fare una chiacchierata con la direttrice Serena Cinquegrana, arrivata a Dakar nel 2021 come direttrice dell’Istituto italiano di cultura dopo un’esperienza ventennale nel settore culturale in Italia, tra Ente Teatrale Italiano, Zetema e Ministero della Cultura.

Siamo oggi nella nuova sede al n 14 Avenue Brière de l’Isle, nella zona centrale di Plateau. Qual è la storia dell’Istituto italiano di cultura qui a Dakar?
Storicamente c’è stato un Istituto di cultura che aprì negli anni settanta e che è rimasto attivo fino a inizio degli anni novanta, e poi fu chiuso fino al 2020. Nel 2019 è quindi arrivata la mia collega Cristina Di Giorgio che si è occupata di individuare uno spazio e di preparare l’apertura dell’Istituto avvenuta poi il 20 gennaio 2020; è stato fatto un grandissimo lavoro di preparazione a cura sua e dell’allora ambasciatore Paolo Venier che purtroppo è scomparso, che ha lavorato tantissimo perché questa antenna culturale potesse riaprire qui a Dakar.
Qual è la missione di un Istituto italiano di cultura?
La missione è la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero e il facilitare il dialogo tra culture. E per fare questo ci sono al momento circa ottantotto istituti, la rete della Farnesina per la cultura (https://www.esteri.it/it/diplomazia-culturale-e-diplomazia-scientifica/cultura/reteiic/ ); ci sono poi anche colleghi che lavorano all’interno di ambasciate e consolati proprio per supportare la cura delle relazioni culturali con i paesi che ospitano. È una missione abbastanza comprensibile, ma non banale in realtà, su cosa significhi promuovere la lingua e la cultura italiana all’estero ciascuna direttrice o direttore ha una propria risposta rispetto al contemporaneo. Questo perché il Ministero degli Affari Esteri dà delle direttive molto precise che però possono essere declinate a seconda della sensibilità del posto, quindi il lavoro richiesto è quello di saper leggere il territorio, capire che cosa ha senso fare e cosa invece no. Qui a Dakar, ad esempio, rispetto a tanti altri Istituti che sono in territori dove c’è una conoscenza a volte anche profonda della cultura italiana, si cerca di avviare progetti di collaborazione con realtà locali per far dialogare la cultura italiana con la cultura locale piuttosto che fare vetrina dei grandi artisti e dei grandi asset culturali.

Qual è la realtà della scena teatrale e della danza a Dakar e in Senegal?
Questo è un paese dove la produzione culturale è estremamente interessante per chi viene da fuori e che non ha magari un occhio su cosa significhi produrre cultura in Africa. È un bellissimo laboratorio ed è anche il frutto di un paese che nei suoi primi decenni di indipendenza [il Senegal dichiara l’indipendenza dalla Francia nel 1960 N.d.R.] ha avuto un presidente poeta illuminato che ha investito molto sul sostegno di una classe creativa e culturale in questo paese, Léopold Sédar Senghor [la politica culturale di Senghor tese a dare forma ad una “arte africana”: quest’arte era strettamente legata al movimento della négritude]. Non è un caso che questo sia uno dei primi paesi dove nasce un École Nationale des Arts e dove venivano formati non solo gli artisti ma a anche altre categorie come ad esempio gli architetti. Il Senegal storicamente è un paese dove le arti, soprattutto la musica e la danza, fanno parte della quotidianità delle persone. Sono tradizioni che si tramandano, basti pensare alla grande tradizione dei griots, che non sono soltanto degli artisti, ma sono anche i cantori della storia locale, sono le persone che tramandano le storie di generazione in generazione e che in qualche modo creano un patrimonio di storie che sono la storia e la cultura orale di questo paese.
Quindi arrivare qui e rendersi conto della quantità di artisti che c’è, è abbastanza impressionante. Artisti che spesso non sono definibili in un settore preciso, cioè chi fa teatro spesso non fa solo teatro, chi fa danza spesso non fa solo danza, e la musica intreccia tutto.
Ci dai qualche riferimento rispetto ad alcune di queste realtà artistiche, così da poterne seguire la ricerca anche da lontano?
Ovviamente c’è una grande differenza tra Dakar e tutto il resto del paese; Dakar è storicamente una città molto cosmopolita. E lo è un po’ anche Saint Louis, nel nord, la vecchia capitale con una storia importante. A Saint Louis ci sono dei festival musicali molto importanti: il Saint Louis Jazz Festival (https://www.saintlouisjazz.org/ ) e un altro festival nato intorno a un grandissimo musicista di kora che si chiama Ablaye Cissoko e che ha fondato un festival che si chiama Au tour des cordes ( https://www.autourdescordes.com/ ) e che celebra gli strumenti a corde provenienti non solo da questa regione ma anche dal Nord Africa, dal Medio Oriente. Musicalmente è molto interessante far venire musicisti italiani per collaborazioni con musicisti locali, che sono straordinari nell’improvvisazione e nella capacità di dialogare. Un aspetto pero’ da non dare per scontato sono gli strumenti musicali che sono disponibili nel paese, ad esempio trovare un pianoforte o un accordatore di pianoforti in Senegal può essere un problema, e limita ad esempio la possibilità di proporre concerti di classica o opera, che sono molto richiesti invece in altre parti del mondo.

E per quanto riguarda il teatro e la danza?
Il Senegal è la sede di una delle più importanti e conosciute realtà della danza prodotta in Africa che è l’Ecole de Sables ( https://ecoledessables.org/ ) creata da Germaine Acogny ( https://www.labiennale.org/it/danza/2021/leone-d%E2%80%99oro-alla-carriera ) Leone D’oro alla carriera a Venezia 2021 e Premio Nonino 2025 ( https://premio.grappanonino.it/winner/germaine-acogny/ ). Ci sono poi diverse realtà molto legate alle tradizioni che scandiscono in qualche modo i momenti di cerimonia della società, per cui tutto quello che è tradizione delle diverse etnie che vivono il Senegal; ogni gruppo ha i propri riti, e i riti spesso sono veramente delle messe in scena che hanno danza, teatro e musica. E spesso ci sono delle realtà come quella dell’ARCOTS Pikine, associazione di attori che ha sede nel Complexe culturel Léopold Sédar Senghor diretto ora dall’attore Laïty Fall, dove tutti i lunedì c’è un incontro fisso con tutte le artiste e gli artisti del territorio con una messa in scena che celebra la ricchezza culturale delle popolazioni del Senegal.
 Siamo stati a Pikine vedere lo spettacolo diretto da Laïty Fall per due lunedì ed è impressionante la partecipazione della “classe” di artiste e artisti del territorio attorno a una stessa opera, come interpreti e come pubblico. Un’utopia se pensata rispetto al contesto italiano. In questo contesto di partecipazione e autoformazione, che possibilità ci sono di formazione professionale, produzione e strategie di produzione?
Siamo stati a Pikine vedere lo spettacolo diretto da Laïty Fall per due lunedì ed è impressionante la partecipazione della “classe” di artiste e artisti del territorio attorno a una stessa opera, come interpreti e come pubblico. Un’utopia se pensata rispetto al contesto italiano. In questo contesto di partecipazione e autoformazione, che possibilità ci sono di formazione professionale, produzione e strategie di produzione?
In Senegal mancano oggi dei riferimenti produttivi accessibili a tutti. C’è da seguire sicuramente la nuova scuola per attori che è stata fondata da Adama Diop, l’EIAD (https://www.eiad-dakar.com/ ) a Dakar; c’è il centro culturale Le Château a Saint Louis, centro culturale che si occupa principalmente di Danza, ma anche di produzione teatrale. Ci sono dei teatri nazionali, il teatro nazionale storico Daniel Sorano con la sua compagnia voluta dal primo presidente del Senegal Sengor, e il Grand Theatre, pensato come un teatro d’opera; ma sono due strutture che fanno fatica ad avere una programmazione perché sono istituzioni che poi non hanno fondi.
C’è una rete di circa quaranta centri culturali regionali del Ministero della Cultura Senegalese diffusi nel territorio e in tutte le regioni; a Dakar ci sono gli spazi pubblici del Centre Culturel Régional Blaise Senghor di Dakar e la Maison de la Culture Douta Seck, due luoghi dove, anche in assenza di fondi, riescono ad accogliere associazioni e compagnie che ne animano la programmazione. Se Dakar è una realtà a sé stante a livello di proposta culturale, i centri regionali sono spesso gli unici riferimenti culturali sul territorio e svolgono anche una funzione sociale rispetto alle comunità. In questo quadro, per gli artisti riuscire a produrre è una vera sfida e richiede la capacità di sapere anche trovare risorse.

Come Istituti di cultura che collaborazione riuscite ad avere con questa scena delle arti performative?
Abbiamo sicuramente un rapporto privilegiato con il KËR Théâtre Mandiaye N’diaye del quale stiamo appunto promuovendo in questo momento il progetto “Bergamo, Ravenna, Dakar andata e ritorno”; c’è un rapporto privilegiato perché il direttore Moussa N’diaye e i suoi artisti sono persone che vivono tra due paesi e sono quindi un punto di riferimento anche per noi. Anche noi siamo molto giovani come Istituto e con Teatro delle Albe e con il KËR Théâtre siamo ormai al terzo, quarto progetto che portiamo avanti, progetti che poi hanno una loro vita anche in Italia e che qui in Senegal ne prendono un’altra diversa a seconda dei contesti.
Abbiamo lavorato molto anche con Massimo Luconi, regista teatrale che frequenta ormai da trent’anni il Senegal e che ha fatto qui diverse produzioni e lavora più o meno stabilmente con un gruppo di attori. Lo scorso anno abbiamo portato in Senegal il progetto che il Premio Riccione Teatro ha realizzato con il Ministero degli Affari Esteri sui nuovi drammaturghi italiani ed è molto interessante quando testi italiani sono declinati alla sensibilità locale, sono interpretati da artisti locali ma con un linguaggio molto contemporaneo. È altrettanto interessante vedere la reazione del pubblico che qui non è un pubblico passivo, reagisce, vuole dire la sua, ride e commenta ad alta voce, ed è veramente un’esperienza da vivere, decisamente diversa da quella italiana.
Che opportunità di progetti, di residenze, ci sono per artiste e artisti italiane ed europee offerti dall’Istituto di cultura, e quali le occasioni di scambio con gli artisti senegalesi?
In questi anni abbiamo cercato di dare spazio soprattutto a progetti centrati su collaborazioni con il territorio e con gli artisti locali, privilegiando ove possibile il rapporto con artisti e realtà culturali italiane che in qualche modo avessero già un interesse e una conoscenza del contesto artistico senegalese. Sono i progetti che a mio parere hanno avuto un più forte impatto e che hanno creato relazioni più durature. Da un certo punto di vista, aggiungerei che sono le collaborazioni più sostenibili, viste le risorse limitate con le quali operiamo che non ci permettono, ad esempio, di poter finanziare residenze di medio o lungo periodo.
Molto difficilmente selezioniamo progetti o proposte “preconfezionate” che ci arrivano massivamente via email, senza una vera comprensione del contesto, o che hanno una finalità più di cooperazione o beneficenza che non è il settore in cui operiamo.

La dimensione linguistica in che relazione entra con la vostra mission culturale, artistica, a partire dall’italiano ma in relazione a una realtà multilingue così vasta?
Spesso qui ci si perde un po’, il Senegal è un paese dove la lingua ufficiale è il francese ma ci sono altre lingue nazionali, il wolof, il sérére, il peul, il mandinga, il soninké e il diola, più altre lingue che sono promosse. La lingua francese è la lingua formale che si impara a scuola e molti non hanno neanche spesso accesso a quel tipo di formazione, quindi è una lingua che non parla il cento per cento dei senegalesi. Qui all’Istituto abbiamo anche insegnanti senegalesi che hanno studiato in Italia e quindi chiaramente sono avvantaggiati nell’essere mediatori tra le lingue. E a proposito di mediazione, nei corsi di italiano adottiamo dei libri di testo che vengono scritti e prodotti in Italia pensati quindi per un pubblico di stranieri in contesti europei e quindi spesso mancano proprio le parole; ad esempio quando si parla di andare in montagna se ci sono persone che non parlano francese non abbiamo una parola in wolof per dire montagna, collina sì, ma montagna non esiste perché banalmente in Senegal non ci sono le montagne. Questa è una cosa che ci aveva fatto scoprire Pap Khouma con il lavoro di traduzione che abbiamo fatto sul primo canto della Divina Commedia insieme al Teatro delle Albe per la celebrazione del settimo centenario della morte di Dante. Quindi è interessante vedere quanto sarebbe utile riadattare alla realtà anche semplicemente i testi di lingua che noi utilizziamo. E con le arti è la stessa cosa. Spesso ci capita di usare il wolof, è la lingua che se abbiamo l’opportunità di utilizzare utilizziamo, anche a partire da un titolo per una mostra o per una rassegna teatrale; ovviamente il teatro è stato l’ambito in cui abbiamo potuto sperimentare di più, perché è appunto l’arte della parola. Quindi sì, un po’ abbiamo sperimentato, però non è facile, ma riusciamo a farlo quando lavoriamo con persone che riescono a vivere a cavallo tra le culture.
Luca Lotano