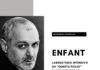Al Piccolo Teatro Studio Melato è andato in scena in prima nazionale Memory of Mankind, spettacolo del regista svedese Marcus Lindeen, artista associato al Piccolo Teatro. Una pièce che affronta l’ossessione umana dell’eredità, tra desiderio di ricordare e necessità di dover dimenticare.

Nel 1995, Jacques Derrida pubblica un saggio Mal d’archive. Une impressione freudienne, risultato di una conferenza che si era tenuta a Londra intitolata Memory: The Question of Archives in cui evidenzia una sorta di patologia contemporanea per la conservazione, un’ossessione umana per il salvataggio della memoria dal suo inevitabile annullamento. Una riflessione che esplora la natura dell’archivio, a partire dall’etimologia della parola, legata al potere e all’autorità (arché), per mostrare come l’archiviazione non sia solo un atto di conservazione, ma anche di selezione ed esclusione, uno strumento al tempo stesso di potere e desiderio. Pochi anni dopo, Marc Augé ne Les Formes de l’Oubli, 1998, suggerisce d’altra parte che l’oblio stesso, lungi dall’essere un nemico della memoria, ne sia invece il fondamento: solo attraverso l’erosione e la perdita si cristallizzano i ricordi.
A distanza di quasi 30 anni, che valore assumono oggi queste riflessioni? In un’epoca in cui, grazie alle tecnologie, tutto è costantemente iper-esposto e catalogabile, sempre disponibile, sempre consultabile, quali sforzi etici e politici ci richiede l’atto (inteso anche come responsabilità) di far memoria, di generare oblio? Oltre all’individuo, come si pone la creazione artistica nei confronti della sua conservazione e trasmissione e qual è il potere, dichiarato e non, degli strumenti di cui si avvale? Sono questi quesiti a minare la mente dello spettatore che si reca a casa dopo aver preso parte – perché di partecipazione si tratta e non più solo di visione – alla prima nazionale di Marcus Lindeen, Memory of Mankind, al Teatro Piccolo Studio Melato di Milano.

Uno spazio performativo circolare, che vede ancora per una volta la firma di Mathieu Lorry-Dupuy, e che potremmo definire quasi democratico per la sua capacità neutrale di stabilire delle traiettorie di “equilibrio” tra chi lo abita, annulla la separazione tra pubblico e attori in sala, che si trovano a condividere l’ambiente scenico come parte di un unico organismo. È un’impostazione documentaria tipica della pratica del regista svedese – che abbiamo già avuto modo di conoscere in L’aventure invisible –, perché costringe ad una certa vicinanza condivisa alla materia e al corpo teatrale stesso, che sarebbe altrimenti impossibile e che chiede all’individuo di avere una postura di attenzione nei confronti del racconto. La forza documentaria viene, tuttavia, costantemente insidiata, messa in discussione, osteggiata e decostruita dall’elemento della finzione: la fedeltà al documento esiste, è reale, ma soltanto sull’ultimo di una serie di livelli narrativi, quello restituito live allo spettatore, partecipante dell’arena. Il meccanismo drammaturgico si sostanzia difatti di una ricerca che Lindeen ha condotto con Marianne Ségol, drammaturga e traduttrice, che prima di tutto è partita da una raccolta di testimonianze per poi proseguire con un lavoro di rielaborazione affidato alla scrittura, di reinterpretazione e registrazione dei dialoghi da parte degli attori (nelle voci di Gabriel Dufay, Julien Lewkowicz, Olga Mouak, Nathan Jousni, Marianne Ségol) e di trasmissione e restituzione in scena di quegli stessi dialoghi da parte di non professionisti (Sofia Aouine, Driver, Axel Ravier, Jean-Philippe Uzan) che li ripetono grazie agli auricolari. In questo modo, gli individui in scena “a loro volta si appropriano di quelle parole (…) in un certo senso sono dei portavoce. Così il rapporto con il presente diventa più immediato”. Ma se la recitazione in differita svuota gli interpreti di un’intenzionalità soggettiva, essa li rende in realtà strumenti documentali, veicoli della storia e testimoni di memorie altre.
Per costruire questo terreno instabile, in cui memoria e sua reinterpretazione si intrecciano con la costruzione del reale, Marcus Lindeen è partito dal progetto omonimo dell’artista austriaco Martin Kunze, che dal 2012 raccoglie e conserva in una miniera di sale, nel cuore delle Alpi svizzere, tavolette di argilla che riportano le tracce del sapere umano. Espressioni del pensiero scientifico, annotazioni storiche, aneddoti di vita quotidiana, incise su supporti di 20×20 cm che fuggono dunque la dimensione smaterializzata del presente (fondata sull’utilizzo di hard disk, iCloud, Google Drive) perché in grado di resistere nella loro tangibilità al tempo e garantire la conservazione della memoria nel futuro.

È questo archivio il punctum dell’intero spettacolo: seduto sui gradoni dell’arena circolare con altri 3 personaggi, il cosmologo Jean-Philippe Uzan nelle vesti di Kunze spiega le origini del suo progetto di archiviazione, facendone emergere le inevitabili derive. Se ogni tavoletta costituisce un atto di conservazione, al tempo stesso essa richiede una selezione dei contenuti, quindi un posizionamento etico ma anche soprattutto politico del soggetto su ciò che deve essere tramandato ai posteri e ciò che deve essere inevitabilmente cancellato (non possiamo far memoria di tutto). Accanto alle difficoltà metodologiche che pone in essere l’archivio di Kunze, Lindeen e Ségol decidono di dar voce ad altre due narrazioni che traslano queste problematicità nella vita quotidiana e che reiterano la tensione costante tra oblio e ricostruzione: è la storia di una coppia, in cui un marito affetto da periodiche e improvvise amnesie si affida alla moglie che, nella volontà di ripristinargli la memoria, gli restituisce un’identità filtrata dalla propria prospettiva e plasmata sui propri bisogni; è la storia anche di un archeologo queer, nella vita un dottorando in sociologia, che, nella volontà di dar voce a ciò che la storia ha tenuto ai margini, nel riempire i vuoti che la narrazione dominante ha sistematicamente lasciato, offre una lettura alternativa rispetto a quella ufficiale di alcune raffigurazioni antiche (in cui i gesti di vicinanza a lungo interpretati come segni di affetto fraterno vengono interpretati come simbolo un amore omosessuale), correndo altresì il rischio di intervenire sulla realtà, manipolandola.
È qui che il regista offre alla riflessione collettiva uno snodo complesso, perché affonda le radici in una materia magmatica, insidiosa, e quanto più attuale. Nell’approfondire il concetto di critical fabulation, elaborato da Saidiya Hartman per colmare attraverso la finzione narrativa i vuoti lasciati dagli archivi tradizionali, Lindeen pone lo spettatore di fronte a un paradosso: la necessità di ricordare si scontra con la consapevolezza che ogni memoria è inevitabilmente una costruzione soggettiva. La finzione può dunque compensare le omissioni della storia ufficiale? O rischia di sconfinare in una narrazione arbitraria, di cui si alimentano molti personaggi politici? Memory of Mankind lascia gli interrogativi così, esposti, nudi nella loro verità, scomodi nella loro eredità, oggetto di dibattito e discussione continua, in un’arena in cui ogni individuo acquista un proprio, personalissimo, diritto di pensiero, diritto di parola.
Andrea Gardenghi
Visto a gennaio 2025 al Teatro Piccolo di Milano
Memory of Mankind
PRIMA NAZIONALE
testo e regia Marcus Lindeen
ideazione Marcus Lindeen e Marianne Ségol
drammaturgia e traduzione Marianne Ségol
voci Gabriel Dufay, Julien Lewkowicz, Olga Mouak, Nathan Jousni, Marianne Ségol
musica e progetto sonoro Hans Appelqvist
scene Mathieu Lorry-Dupuy
luci Diane Guérin
costumi Charlotte Legal
con Sofia Aouine, Driver, Axel Ravier, Jean-Philippe Uzan
casting Naelle Dariya
stage manager David Marin
tecnico del suono Nicolas Brusq
tecnico video e luci Boris Van Overtveldt
tecnico per il montaggio Thomas Nicolle
manager di produzione Emanuelle Ossena, Charlotte Pesle Beal, Lison Bellanger | EPOC produzioni
produzione compagnia Wild Minds
coproduzione T2G Théâtre de Gennevilliers – CDN, Festival d’Automne à Paris, Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Comédie de Caen – CDN de Normandie, Le Méta – CDN Poitiers Nouvelle-Aquitaine, Nouveau Théâtre Besançon Centre dramatique national, Le Quai CDN Angers Pays de Loire, Kunstenfestivaldesarts Bruxelles, Wiener Festwochen, Le Grand T Nantes, Le Lieu Unique Nantes, PEP Pays-de-Loire
con il sostegno di Fondation d’entreprise Hermès
con il supporto di ADAMI
progetto sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione regionale degli affari culturali dell’Île-de-France
scenografia realizzata dai laboratori scenotecnici del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e del Nouveau Théâtre Besançon Centre Dramatique National