A partire da Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello, un viaggio attraverso il concetto di identità, la solitudine di chi vive nella marginalità e vive una relazione non paritaria con l’altro da sé.
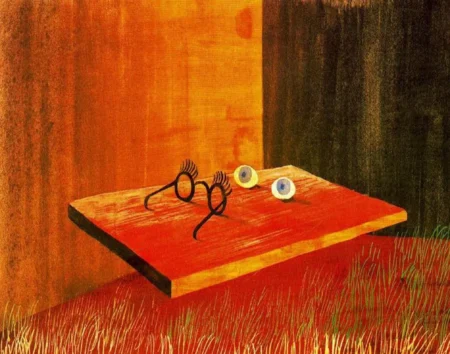
C’è un personaggio, al centro di una casa forse non così grande, ma che grande si percepisce a confrontarvi la vastità della sua solitudine. Quel personaggio ha tratti maschili, ma via via nel racconto, nella voce, nei movimenti e nelle azioni che sviluppa, manifesta una concezione femminile del proprio stare al mondo, a partire dal nome, Jennifer, che già dal titolo della pièce fa emergere la peculiarità del contrasto: questo testo di Annibale Ruccello, Le cinque rose di Jennifer rappresentato per la prima volta nel 1980, ritorna sul palco per mano di Gabriele e Daniele Russo, regista e attore (con Sergio Del Prete) di questo spettacolo en travestie diventato ormai un classico dell’autore napoletano, scomparso troppo presto nel 1986. La relazione tra lo spazio e la solitudine è ciò che maggiormente colpisce lo spettatore, perché quella stanza, il suo luogo, fa da cassa di risonanza proprio alla solitudine attraverso la radio, sia che trasmetta canzoni famose sia che trasferisca altre solitudini per mezzo di un programma d’ascolto, oppure attraverso le telefonate che raggiungono Jennifer sempre, forse, per una “interferenzia” che la mette in relazione con il mondo che, tuttavia, non la cercava.

Si era alla fine dei Settanta – ma la situazione non cambierà di lì al decennio successivo – e Jennifer vive, più o meno si può dire che viva, nel quartiere dei travestiti, i “femminielli” napoletani, una sorta di ghetto che gli stessi abitanti però riconoscono come un manifesto identitario, richiamando una tradizione che risale molti secoli fino a situarsi nella cultura napoletana priva di discriminazione. Eppure quello strato di differenza avvolge il personaggio, lo connota fino al punto di farne esplodere in scena non la recriminazione ma l’abbandono, la sottrazione alla società e, dunque, alla vita. Questa solitudine è, dunque, causa estrema di una relazione mancata o, almeno, traviata da un senso di inferiorità connesso al sistema sociale di appartenenza: Jennifer vive sola, attorno vivono altre persone sole, cercate solo per soddisfare appetiti. E se dunque loro sono cercate, non possono cercare nessuno, la relazione con l’altro non è mai paritaria o equilibrata, rimarcando perciò una differenza che amplifica la loro condizione.

Sono passati oltre 40 anni da allora, forse una Jennifer di oggi vive in un sistema più protetto, la sua “alterità” ha raggiunto una dignità tale che la società non la accetta – si badi a vedere i tanti difetti legislativi in merito – ma almeno la tollera, la riconosce in virtù della propria, si direbbe “particolare”, identità. Il suo squillo del telefono si è trasformato, l’attesa di essere contattata oggi sarebbe probabilmente assorbita dai social network, quella illusione di relazioni che copre il bisogno e, forse, addirittura lo enfatizza; ogni categoria sociale che vive una condizione definita speciale ricerca nella propria bolla una riconoscibilità, per mezzo del dolore condiviso, del confronto esperienziale che abbia nell’altro una ricorrenza, perché attraverso di esso ci si possa dire parte di qualcosa. E così fioriscono, tra i tanti, gruppi d’ascolto legati alle infinite malattie di cui si possa soffrire, social dedicati al contatto reciproco tra migranti che hanno affrontato un viaggio a rischio della vita, ognuno perché sia data dignità alla propria esperienza tramite l’esperienza dell’altro. Ma, ci si domanda: una differenza si riconosce nell’altra? Un malato grave di cancro prova consolazione dal confronto con un migrante arrivato su un barcone nel Mediterraneo? No, probabilmente non è la relazione con l’altro a confortare, ma la relazione con un altro che ci somiglia in tutto e per tutto: un altro che non è l’altro, ma è me.
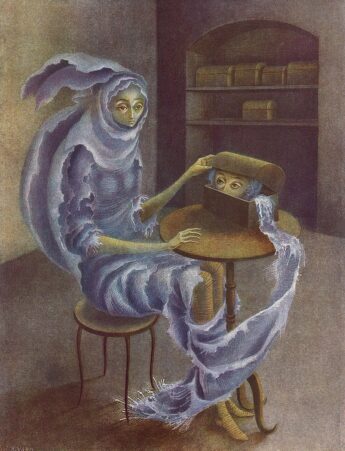
“Io è un altro”, tuonava dai propri versi Rimbaud. Ma oggi questa frase perentoria sembra come diluirsi in una vacuità nullificante, peraltro esacerbata dalle scelte imposte da un algoritmo che innesca quel certo tipo di vana connessione. A corroborare questa idea torna comodo uno studio recente sulle relazioni umane dell’università di Harvard (iniziato tuttavia negli anni Trenta) che traccia il tempo medio di attività solitaria di un individuo e stabilisce come nel 2018 un americano abbia passato da solo in media 11 ore al giorno (al di là ovviamente del tempo dedicato al sonno), ma ne avrà ovviamente percepite molte meno per la messa in rete della relazione, ignorando, come conclude lo studio, che “la solitudine ha effetti sul corpo, può rendere le persone più sensibili al dolore, inibire il sistema immunitario, ridurre le funzioni cerebrali”.
In uno scritto di Italo Calvino a proposito dell’identità, uscito nel 1977 sulla rivista Civiltà delle macchine e riapparso su Repubblica di recente, l’autore di Palomar (che non a caso tratta i rapporti tra l’Io e il mondo) scriveva che “L’identità dell’individuo è caratterizzata soprattutto dal nome, cioè dal suo posto nella società e dalla relazione con ciò che sta fuori dal gruppo in cui ci si riconosce”; ecco come per Calvino l’altro in modo talmente limpido influisce sul sé, così dunque da poter dire infine come sia “il fuori che definisce il dentro”. Ma in questo meccanismo di relazione bidirezionale chi è avvolto dalla solitudine, come la Jennifer di Ruccello, non si riconosce se non come diverso, appendice di una società capitalista che privilegia categorie umane presenti nel ciclo produttivo; ne sanno qualcosa i cosiddetti “invisibili” che vivono per la strada e sui quali lo sguardo dei passanti si sofferma unicamente con piglio giudicante o compassionevole (anche se proprio di recente a Roma è iniziato un bel progetto del Comune almeno di censimento sui senzatetto, sull’esempio di Parigi e Berlino); per costoro lo sguardo dell’altro è allora una definizione di superficie rispetto al sé, un giudizio complessivo che identifica unicamente i limiti della condizione e non il valore della persona.

In conclusione, se la società identifica l’individuo secondo la capacità di costruire relazioni – come già affermava Aristotele e come anche Omero nell’Odissea sembra voler intendere parlando della inciviltà dei Ciclopi, incapaci di stabilire un sistema di solidale compresenza – è bene che quelle relazioni si sviluppino a partire da una condizione egualitaria, altrimenti il piano d’osservazione è distorto e Rimbaud lascerebbe il posto al poeta franco-egiziano Edmond Jabès, quando scrive: “Tu sei qui, ma il luogo è così vasto che essere l’uno accanto all’altro è già essere tanto lontani da non riuscire né a vederci né a sentirci”. Non ci resterebbe allora altro che l’auto osservazione, il nostro riflesso senza contraddittorio, a patto che non finisca come nel racconto del russo Valerij Brjusov (contenuto nei Racconti dell’Io che hanno certo un debito con il Dorian Gray di Wilde e con il Pirandello di Uno, nessuno e centomila) in cui il personaggio, funestato dalla presenza del proprio riflesso nello specchio, inizia a pensare di essere lui la proiezione e l’altro, che gli assomiglia in tutto e per tutto, il vero Io.
Simone Nebbia











