Nel 1984 esce per Einaudi una riscrittura di Eduardo De Filippo de La tempesta shakespeariana. Dello stesso anno è una registrazione in cui il drammaturgo e attore napoletano presta le voci a tutti i personaggi maschili, con l’ausilio tecnico del regista Gianfranco Cabiddu. Lo scorso maggio La Repubblica Napoli ha curato una riedizione de La tempesta eduardiana per la, prima volta dopo quasi quarant’anni. Un approfondimento

William Shakespeare è nome che basta a sé stesso. Per alcuni vale quale concrezione del teatro stesso, per altri come viatico di imperituro accesso a ciò che semplicemente riguarda la sfera dell’umano. La tempesta va in scena per la prima volta nel 1611 ed è acclarato dalla storia come sia l’ultima opera interamente composta dal Bardo. Altrettanto acclarata è la constatazione della sua complessità. Al suo interno si condensano, per struttura drammaturgica, tematica e concezione di base varie istanze che pertengono all’opera di Shakespeare nella sua totalità, tanto che alcuni vi ravvisano un compendio della stessa, facilitati pure dalla sua collocazione cronologica, trovando nelle parole e nella figura di Prospero una sorta di parallelo e di congedo. Tra le annotazioni e le osservazioni di critici e studiosi torna quella su un recupero e un utilizzo delle unità (tempo, luogo e azione) sconosciuto alla gran parte delle opere shakespeariane. È Agostino Lombardo a leggere questa specifica come uno degli emblemi del viaggio che lo spettatore compie con La tempesta, e insieme al suo autore, rispetto alla propria centralità teatrale, decretando in questo modo una sorta di ribaltamento dell’asse analitico, focalizzato sul senso più che sulla forma: «Ed è per questo che, a mio avviso, La Tempesta non è l’addio di Shakespeare al teatro ma, al contrario, il terreno di una nuova, e grande, proposta teatrale. La proposta di un teatro che non sia spettacolo ma esperienza, non imitazione o riflesso o sospensione o fuga dalla vita ma vita esso stesso, e ciò non certo nel senso di una identificazione naturalistica (e dunque illusionistica) tra vita e teatro, ma nel senso che lo spettatore – che ne è protagonista – riceva, attraverso l’azione teatrale, gli strumenti […] del conoscere».
Mutuando le parole di Lombardo diremo che con tale proposta si sono confrontati nel tempo e in vari modi in molti, rispetto ai quali potrebbe bastare citare Peter Brook o Giorgio Strehler. Ma non qui, perché quanti abbiano confidenza con la figura di Eduardo De Filippo sanno che alla fine della sua parabola di vita e di teatro vi è una riscrittura de La tempesta. Conosciuta e citata da cronache e trattazioni, ha assunto per anni e non a torto quasi la connotazione di un tesoro decantato, ma difficilmente raggiungibile. Negli anni Ottanta è Einaudi a proporre ad Eduardo di riscrivere un’opera shakespeariana per inserirla all’interno della collana Scrittori tradotti da scrittori. Dopo quell’edizione, divenuta sostanzialmente introvabile, più nulla sino alla recente pubblicazione per La Repubblica Napoli che, con il sostegno della Fondazione e il beneplacito della famiglia, lo scorso maggio l’ha inserita in un dittico insieme all’Amleto di Antonio Piccolo sotto la dicitura Shakespeare e Napoli, dando seguito in qualche modo ai due volumi di Effetto Eduardo (curati da Giulio Baffi) usciti l’anno precedente.
Nell’approcciarsi alla richiesta di Einaudi, Eduardo pensa a La dodicesima notte, a Sogno di una notte di mezza estate, poi decide per La tempesta, secondo la moglie Isabella Quarantotti «[…] per il carattere sognante e magico. […] Anche l’amore tra padre e figlia e il fatto che Prospero fosse stato tradito dal fratello erano motivo di interesse per lui». Pure nel suo caso sarà l’ultima opera. Inizia dalla versione di Quasimodo, ma l’abbandona presto, allora lavora con Isabella che traduce letteralmente dall’inglese del Penguin Shakespeare con all’occorrenza l’ausilio del dizionario Oxford. Scena per scena, lei riporta tutto su fogli scritti in caratteri marcati e molto grandi per facilitare la lettura a Eduardo, ormai poco assistito dalla vista. Legge le favole dell’Abate Sarnelli, La ciucceide di Nicolò Lombardi, certamente il Cunto di Basile con l’intento di recuperare la struttura e il suono del napoletano seicentesco. Se già nel testo shakespeariano ci sono dichiarati seppur non così decisivi rimandi alla città partenopea, è ovvio come tuttavia la trasposizione linguistica e l’interpolazione di certi elementi drammaturgici (soprattutto per le parti comiche) ricalibri la dimensione di accadimento dell’azione almeno in parte, conservandone però lo spessore ritmico, la diversificazione di registri, il nucleo sostanziale. Eduardo De Filippo non è un filologo e tecnicamente non è un linguista. É un uomo che l’autista in macchina guarda diventare granitico e piccolo quando muore sua figlia Luisella al Terminillo mentre lui è al Quirino, che dal brusio delle voci in platea riesce a capire “di quanto sarà l’incasso”, che per la disciplina del sipario ha sottratto aliti ai polmoni. Quindi la sua scrittura (si) tradisce e si versifica, fraseggia, senza sconfessare l’intento di cui sopra, in una lingua valevole precipuamente per l’ “economia” del regno cui appartiene, una dimensione nella quale la compresenza è un assunto eterno del qui ed ora, una lingua del e per il teatro, fatta perciò di quelle che, ancora una volta mutuando un’espressione di Lombardo, sono “parole di voce e non di inchiostro”. Una lingua che ha, dentro e fuori dalla pagina, ancor prima di venire concepita, suoni, melodie, espressioni, movimenti e gesti, ascoltati, compiuti, guardati, o pensati da chi ha orecchie e corpo e occhi veri solo in palcoscenico. Forse è questa la via lungo la quale sembra avverarsi maggiormente la corrispondenza tra l’originale del Bardo e la versione eduardiana, il piano su cui assurge più alta al concetto di traduzione.
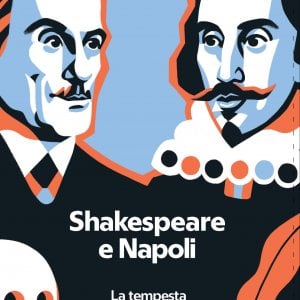
Volendo andare a recuperare tracce pregresse del grado di relazione tra Eduardo e Shakespeare si potrebbe guardare a La parte di Amleto (1939), ai riferimenti contenuti ne L’arte della Commedia, ma verremo inevitabilmente condotti anche altrove. Nel 1980 riceve una laurea honoris causa a La Sapienza di Roma e già nel suo discorso i riferimenti a parole del Bardo non sono difficili da rintracciare. Gli anni che seguono però sono quelli delle Lezioni di drammaturgia con Ferruccio Marotti al Centro Teatro Ateneo, da cui viene fuori L’erede di Shylock – basta il titolo per un rimando al Mercante di Venezia – , dato alle stampe da Luciana Luppi sul soggetto che Eduardo aveva proposto agli studenti, cui precisava: «C’è un avvertimento che voglio dare un po’ a tutti voi: non abbiate soggezione di Shakespeare. Noi viviamo in un’altra epoca. Dobbiamo fare un’opera contemporanea». É sempre durante le Lezioni che Eduardo parla di “Guglielmo, Shakespeare” come “il primo classe”, tuttavia la sua stessa. Marotti in un’intervista rilasciata a Paola Quarenghi spiega: «L’uomo di teatro vero per lui era quello che recita quattordici volte la settimana. E Shakespeare gli era vicino da questo punto di vista: era uno che in teatro poteva fare tutto: scriveva, era azionista della propria compagnia, dirigeva gli attori, recitava, faceva il fantasma nell’Amleto… Era dentro il teatro. E per Eduardo c’era una comunità ideale di cui facevano parte Shakespeare, Molière, queste persone che secondo lui erano il teatro». Il limen di azzeramento di qualunque distanza e la cessazione di qualunque ulteriore necessità di congiunzione concettuale o storiografica si trova quindi nella soglia tra palco e platea.
Ci sono nomi che ricorrono a proposito de La tempesta, quelli degli storici o dei biografi e i pochi di chi ha partecipato, o sarebbe meglio dire ha accompagnato e assistito quel processo naturale e governatissimo, imprevedibile e fisiologico, in cui La tempesta è “accaduta”. Tra quei nomi anche quello di Gianfranco Cabiddu. Docente presso il centro sperimentale di cinematografia, regista con all’attivo documentari e pellicole di finzione, nel 2016 ha vinto un David di Donatello per la sceneggiatura de La stoffa dei sogni, film ispirato a L’arte della commedia e a La tempesta nella versione eduardiana, oltre che originale. Negli anni Ottanta sarà lui, allora proveniente dagli studi di etnomusicologia al DAMS di Bologna, a trovarsi a collaborare con Marotti e il CTA, a registrare le Lezioni, e l’audio di quella ri-scrittura, in cui Eduardo presta la voce o meglio le voci a tutti i personaggi maschili (l’unica voce femminile è di Imma Piro). Si avvera lì la distillazione straordinaria di tutta la coscienza teatrale di un drammaturgo, capocomico, attore, direttore di scena e chissà quanto altro, di tutto “l’uomo di teatro” e, forse, di tutto il teatro nell’uomo.

Cabiddu si profila ai miei occhi come un testimone privilegiato, per molti aspetti unico, a cui porre domande o da cui cercare di trarre, fuori dagli interventi contenuti in vari scritti, impressioni, stralci diretti di memoria, lasciti di vario grado e livello. Alla ricerca di un contatto, ricevo il suo numero di telefono da un amico comune. Provo a chiamarlo in una mattina di inizio agosto con il piccolo nodo di tensione di chi ha l’impressione di accostarsi al detentore sconosciuto di un privilegio. La sua voce denuncia a tratti un’inflessione fonetica da cui l’orizzonte della Sardegna non è mai stato espunto. Ci diamo un appuntamento telefonico per le 11:00 del giorno successivo, e quel nodo si scioglierà in una conversione accogliente e accolta, compitata da una serie di questioni appuntate cercando di governare e ammansire la ricerca di una completezza che ho sempre saputo provvidenzialmente impossibile.
Mi racconta del trasferimento in estate nella casa di Velletri dove sono avvenute le registrazioni e dove si è trovato a costruire uno studio in cui lavorava solo con Eduardo, chiamato dalla Quarantotti “la grotta di Prospero”. «Noi lavoravamo di pomeriggio, poi io montavo le varie versioni perché c’erano tanti take di ciascuna metà pagina e, considerando anche che cambiava voce per ogni personaggio, avevo un registratore con tutti i provini delle voci. Gli facevo risentire le intonazioni che lui stesso aveva inventato per ciascuno, per intonare poi la pagina. Avevamo provato a fare registrazioni separate, ma a lui veniva meglio andare avanti per il ritmo della recitazione […] quindi domandando, rispondendo e interagendo in diretta, non facendo le parti di un personaggio e poi separatamente le parti dell’altro. […] Io facevo le registrazioni e lui era dall’altra parte del tavolo. Diveniva regista di sé stesso quando l’indomani sceglieva quello che avevo messo come “buone”. Ricordo che una volta, finita una pagina di lettura mi ha detto “Beh come è venuta?” e io, ovviamente in soggezione perché ero anche molto giovane, gli ho detto “Ma tecnicamente è buona”. Lui è andato dall’altra parte (mi dava sempre del tu, ma mi dava del lei quando si alterava, seppur affettuoso) e mi ha detto “Qui ci siamo solo io e lei, per cui è lei che mi deve dire se ho fatto bene o ho fatto male”». Quando gli chiedo quanto o come la “severità” eduardiana si applicasse a sé stesso mi spiega: «Ogni tanto diceva “mannaggia, questo corpo che non mi assiste più!” […] Avrebbe voluto essere più energico per come era energica la testa. Era rigidissimo, abbiamo rifatto un sacco di volte le stesse parti, e non c’era una prospettiva chiarissima ancora di cosa potesse diventare quest’opera. […] Diceva “questa cosa è venuta male” o “questa scena comica non ha il giusto ritmo”, per cui si rifaceva e l’arricchiva magari con delle paroline, con delle cose che non ci sono sul testo, rendendola in qualche modo più viva. Pretendeva molto da sé come attore perché era una bella fatica cambiare personaggio cambiando voce… Chiedeva uno sguardo esterno per la parte tecnica ovviamente, ma anche per il ritmo: se vedeva che ridevo sotto i baffi gli faceva piacere. Stava recitando davanti a un microfono e dimenticava che facevamo una registrazione: era come se io fossi il pubblico, non un tecnico in camice bianco, per cui ci voleva una risposta viva in qualche modo. […]». Mi racconta di quando a Montalcino Eduardo recitò per l’ultima volta la scena del balcone di Questi Fantasmi e di come il pacemaker abbia fatto interferenza nell’audio, generando il panico in lui prima e rivelando poi, invece, nei fatti “il cuore (che) ha tremato sempre, ad ogni prima rappresentazione”. Rispetto all’introduzione che De Filippo fece in quell’occasione, in cui specificava la necessità di una recitazione “non verista” e nella quale accennava pure alla Commedia dell’Arte, gli domando cosa gli sia rimasto come una differenza di quel genere di impostazione, di quella percezione del mondo riferita al mestiere. Mi spiega: «Mi torna e rimane l’idea dell’uomo di teatro, ovvero un uomo che nel suo lavoro comprende il pubblico, […] per cui gli “a parte” sono una tecnica per tirare dentro al palcoscenico la “complicità” del pubblico […] È tutto verosimile, ma è verosimile in quella complicità. […]». Nel procedere della conversazione faccio riferimento alla fantasmagoria insita ne La tempesta shakespeariana per capire dalla sua prospettiva in che modo questa si sia riconvertita all’interno della registrazione: «Eduardo non finì l’opera, non riuscì a completarla, mancavano pochissime cose. Saltammo i masques e registrammo l’epilogo che fu travolgente, questa sorta di addio al teatro. Lì lui traduce il rumore dell’applauso come liberazione del pubblico a un attore, come sommo congedo. Non ricordo le parole esatte in napoletano, ma c’è un riferimento concreto al rumore del battimani che libera da questa sorta di prigione in cui un attore ogni sera si caccia. Quello che non siamo riusciti a finire è la partitura sonora, dei rumori, l’interazione con tutti gli ambienti: è impossibile che in quest’opera non si sentisse il mare, è come previsto nelle parole che si sentisse. […] Oggi la tecnologia permetterebbe una spazializzazione del suono e quindi quello che, molto rozzamente, avevamo fatto nell’atto primo scena I. Consentirebbe di far convivere le voci immerse dentro un ambiente che aderisca alle scene, come fosse una scenografia sonora. Questo probabilmente restituirebbe la grandezza di quella registrazione in cui già così, chiudendo gli occhi, si riescono a immaginare tutte le location. Me lo sono sempre posto quale il punto d’arrivo di quell’opera che, effettivamente, tutta completa non ha mai visto la luce». Provo a indagare con lui i termini tradizione e tradimento, anche alla luce del ritorno a quell’esperienza con un film. Mi precisa: «Io la penso come Eduardo: la tradizione è quello che abbiamo alle spalle e che ci consente di fare un passo avanti, di fare il passo successivo se ricordiamo da dove veniamo. Sono tornato a quel testo in modo abbastanza naturale. Me lo sono portato dietro per anni, penso sia normale se si fa una cosa così importante durante la formazione. Quando sono arrivato sull’isola dell’Asinara […]mi sono ritrovato sull’isola di Prospero […] Automaticamente mi è venuto in mente il testo de La tempesta e un ragionamento su come si potesse fare una storia nuova, che fosse anche un omaggio a quello che mi era rimasto dentro il cuore […]». Per concludere gli chiedo di restituirmi due immagini, mi risponde che gli resta certamente l’immagine di una persona molto attenta e affettuosa, insieme alla “fiducia” e un immediato “senso di responsabilità”.
«Se non dovessi tornare,/sappiate che non sono mai/partito./Il mio viaggiare/È stato tutto un restare/ qua, dove non fui mai.» scrive Giorgio Caproni in Biglietto lasciato prima di non andar via, e i versi ci arrivano alla mente, per caso, per associazione o per necessità. Siamo tornati, torniamo già e torneremo ancora. Eravamo saldi eppure eravamo già persi, perdiamo e ci perderemo ancora. Forse o forse no. Perché è tornata e torna, l’abbiamo persa, ci ha perduti e forse ci perderà ancora. La tempesta è nelle cose. Per un attimo, una sera, per una notte, per un mese, per sempre.
Marianna Masselli














