Intervista alla perfomer, attivista e ricercatrice Ilenia Caleo, a partire dal volume di cui è autrice Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista.
Incontriamo Ilenia Caleo, perfomer, attivista e ricercatrice, in un café di Piazza Vittorio a Roma, dopo aver attraversato il suo Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista, edito da Bulzoni nel 2021. Esplorazione di un universo di pensiero e pratiche in espansione intorno alla scena femminista e queer, il lavoro di Caleo stempera il rigore accademico con la vitalità interstiziale della biografia, l’effluvio di autori e autrici convocat* fra le pagine della trattazione con la memoria viva di un archivio personale di lavori vissuti a distanza ravvicinata sulla scena sperimentale degli ultimi anni. Così Spinoza, Foucault, Deleuze, Butler, Haraway e Braidotti dialogano con tante artiste a artisti che abbiamo incontrato fra festival e spazi indipendenti, o di cui abbiamo appreso dal dibattito internazionale: Sasha Waltz, Cristina Kristal Rizzo, Xavier Le Roy, Simon Aughterlony, Eszter Salomon etc… Materialismo non è qui un cielo svuotato, ma l’intensità dei corpi liberati da sovrastrutture millenarie. Nella pagine del libro percepiamo tracce di un pensiero generativo, accenni danzanti di risposte possibili alla domanda che ci portiamo come un mantra dalla lettura: come rifare mondo?
Performance, materia, affetti. Una cartografia femminista è il titolo del tuo libro. Da quale prospettiva osservi il vasto concetto di performance?

Performance, materia e affetti sono tre concetti-laboratorio, tre campi di creazione e di immaginazione, tenuti insieme da una prospettiva di teoria politica femminista. Il concetto di performance è letto a valle di una ricognizione sui dibattiti contemporanei che si sono aperti a partire dagli anni novanta, quando il termine ha valicato il confine dei performance studies per rivestirsi di un significato politico, facendosi paradigma con cui leggere il presente. Tenere insieme i due ambiti, la sperimentazione artistica e politica, è un asse fondamentale di questo lavoro, come del mio percorso biografico. A voler percorrere una personale genealogia del concetto di performance, metterei al centro la questione e la filosofia del linguaggio, mio ambito di specializzazione filosofica – mi riferisco in particolare al pensiero di Wittgenstein (per me determinante, prima ancora di Austin e della filosofia anglosassone) che definisce il linguaggio una pratica, un campo d’azione, un fare, arrivando poi a Judith Butler che ne farà uno strumento di analisi della politica dei corpi e delle sessualità, di come questa si istituisce e si cristallizza in abitudini sociali e norme, ma anche di come si può sovvertirla. Linguaggio e mondo stanno in una relazione bidirezionale, dinamica – il linguaggio plasma ciò che ci circonda, fin nelle pieghe della materialità. Eccoci dunque all’urgenza della materia: interrogare il pensiero del corpo, rompendo la dicotomia secondo cui il pensiero avviene altrove rispetto ad esso, e dunque condannando il corpo a un vuoto di pensiero e di storia.
La materia dunque appare con gli affetti, sin dal titolo, parte di una triade non gerarchica.

La coreografia dei corpi, la spazialità, la costruzione della postura / del gesto sulla scena artistica e politica illuminano una filosofia della corporeità, aprendone prospettive inedite a contatto con la teoria. Il pensiero femminista ha indagato lo statuto dei corpi e della materia, denunciando la profonda condanna del corpo che attraversa le correnti egemoniche del pensiero occidentale, secondo cui la materialità sarebbe inerte, priva di forma, ciò che non-parla. Il pensiero intorno alla materia, portato avanti nell’eterogeneità dei “nuovi materialismi”, intreccia il pensiero sulla performance proprio ove si rifiuta l’inerzia della materia, riconoscendo come anch’essa agisca, si comporti, sia appunto performativa. Un’evidenza che ci restituisce anche la fisica quantistica, che dimostra come la materia possa essere, alternativamente, onda e particella – la domanda non è più cosa è?, ma come agisce?. Penso alla filosofa Karen Barad che confuta che la performatività sia una prerogativa umana, e allarga questo concetto elaborato dal pensiero queer. La capacità di agire non è monopolio dell’umano: molte sono le forze che agiscono sulla scena, in una scrittura non meccanica, non deterministica. Bisogna riconoscere che questo sconfinamento di possibilità è già profondamente in sintonia con le pratiche artistiche più avanzate: molte artiste/i/^ hanno già acquisito questi orizzonti teorici, ci stanno lavorando dentro. La svolta affettiva si inserisce in questo slittamento epistemologico: pensare gli affetti in quanto forze che producono continue transizioni, passaggi di intensità e di stato della materia – siamo dentro una logica del sensibile: sensazioni, percezioni, affetti, memorie. Lo sperimentiamo continuamente: passare dalla gioia alla tristezza, dall’impazienza del futuro alla malinconia della perdita e viceversa, percepire il divenire incessante che siamo. È Spinoza che, nella genealogia filosofica, rimargina il taglio cartesiano e prova a tenere insieme materia estesa e materia pensante, non come due cose separate, ma come due modi della stessa sostanza. Gli affetti, ci dice Spinoza, sono forze materiali, concrete. Possiamo fare un esercizio di immaginazione, e intravedere nel pensiero spinoziano la descrizione di vere e proprie coreografie di affetti e composizioni materiche, profondamente risonanti, oggi, con molte delle ricerche coreografiche più avanzate. Ragionare per affetti è un modo non-rappresentativo di discorsività politica e scenica, poiché muove l’attenzione dallo stato delle cose alle trasformazioni, consentendoci di rendere visibile l’invisibile. Attenzione però: gli affetti non sono qualcosa di privato, di interiore e separato. Non accadono, secondo il senso comune, nel teatro dell’io, ma in un’economia pubblica dello scambio.
La performance come strumento di critica politica. Si evidenzia però da più parti come la nostra sia una “civiltà della performance” per intendere un vortice in cui la soggettività è asservita totalmente a logiche produttive e alla ricerca di una condizione di sempre maggior benessere e visibilità.

Il concetto di performance ha una stratificazione che misura proprio la presa del concetto sul reale, presa tanto più forte quanto più è capace di coglierne anche le contraddizioni. A tal proposito è utile osservare il dibattito sull’ontologia della performance vivo già negli anni novanta in seno ai performance studies: secondo Peggy Phelan, la performance è costitutivamente un luogo di resistenza, in quanto non produce opera, sottraendosi così al circuito del consumo. A differenza delle altre arti, dunque, essa sarebbe ontologicamente destinata alla sparizione. Da qui si è aperta una discussione ampia su come si possa fare archivio della performance (e degli affetti); parallelamente sul fronte della critica dell’economia e delle forme di produzione si è rilevato come l’oggetto-merce, la produzione in fabbrica, receda di fronte al lavoro senza opera: pensiamo al lavoro di riproduzione o dell’industria culturale, ai linguaggi di programmazione e all’informatica, alla centralità delle relazioni e dei network e, dunque, anche al lavoro creativo. Dobbiamo la fertilità di queste teorie critiche proprio al pensiero italiano, da Toni Negri a Paolo Virno, da Cristian Marazzi a Cristina Morini, troppo poco acquisito dentro gli studi teatrali in Italia. Il capitale ha avuto una grande capacità di messa al lavoro, e dunque di sfruttamento, delle risorse performativo-affettive-relazionali. Ecco dunque l’assottigliamento del confine fra vita e lavoro, un confine che è sempre stato labile proprio nelle arti, in passato con un valore affettivamente positivo di identificazione fra passione e professione. Dobbiamo dunque sollecitarci a leggere le nuove forme, spesso invisibili, di autosfruttamento proprio nel nostro settore, perché certamente il lavoro immateriale non è più un privilegio. Dunque la performance può essere uno strumento di resistenza, per tutto quanto detto finora, ma anche un campo di sfruttamento. Non è necessario risolvere questa dualità, che semmai restituisce lo spessore operativo di uno strumento pratico e teorico, la sua presa, appunto, sul reale. Tenere insieme le due dimensioni, nella complessità.
Il tuo libro, cito Annalisa Sacchi nell’introduzione, rende possibile l’incontro finora mancato in Italia fra performing arts e “discorsività transfemministe e queer”. Manca o è mancata nel nostro paese una critica femminista non-accademica?

Il femminismo italiano nasce, in realtà, proprio a stretto contatto con la pratica e il pensiero artistico. Penso a una figura come Carla Lonzi nella preziosa rilettura che ne fa la storica dell’arte Giovanna Zapperi, a quelle insenature degli anni ‘70 in cui il campo della sperimentazione, non essendo presidiato da catture istituzionali o di mercato, offriva terreno fertile per nuove soggettività. Ciò che Sacchi intende, ciò che proviamo a dire insieme e su cui proviamo anche a intervenire, fondando una Magistrale di arti performative con un corso di laurea (unico in Italia) titolato “Studi performativi e di genere” presso lo IUAV di Venezia, è che l’accademia ha raccolto poco da quelle sperimentazioni. Questo è dovuto a diverse ragioni. Da un lato il femminismo in Italia, rispetto a quello anglossassone in cui i dipartimenti di Women studies nelle università nascono molto presto in una strada di istituzionalizzazione, è invece storicamente orientato a scelte alter-istituzionali, di autonomia. Pensiamo ai consultori, che nascono proprio negli anni ’70 come forme di self-help e di autorganizzazione della cura, ma anche di archiviazione e condivisione di saperi del corpo, e poi al fiorire di case editrici e librerie indipendenti, al femminismo underground delle riviste, della scena culturale e musicale… Si tratta di luoghi più esposti e più fragili, e più facilmente le trasmissioni diventano intermittenti, discontinue. Oggi viviamo in un orizzonte nuovo, dove gli ambiti di produzione indipendente o underground non sono più così nettamente separati come fino a tutti gli anni novanta: i tentativi che si moltiplicano provano piuttosto a occupare anche luoghi più istituzionali per hackerarli, per ibridarli. Al tempo stesso è bene denunciare che gli studi teatrali in Italia, con le dovute, singolari eccezioni sono ancora impermeabili alle metodologie e alle epistemologie più avanzate degli studi culturali, del post-strutturalismo e del femminismo degli ultimi anni. L’effetto è una disconnessione degli studiosi accademici dalle pratiche della scena – non sono più interlocutori/interlocutrici del lavoro di artiste/^, non frequentano i festival, non sanno leggere la scena contemporanea e le nuove drammaturgie. Pensiamo ad esempio alla presenza drammaturgica e compositiva delle nuove ecologie nella ricerca scenica, o delle questioni legate alle identità e alle questioni decoloniali, e a come queste letture siano assenti dai programmi accademici, ritenute estranee alla disciplina teatrale. Spesso l^ studenti sono più in contatto dei loro docenti con queste ricerche, ma è necessario fornire e inventare strumenti critici per costruire le genealogie, per riconoscere i collegamenti tra cose distanti, per scrivere nuove storie/storiografie solide. Il rischio sennò è annegare in un presente senza storia, tutto di consumo: leggere Fisher senza riconoscervi Marx, Preciado senza il post-operaismo, lo xenofemminismo senza la pluralità dei dibattiti su naturacultura, da de Beauvoir in poi. Detto ciò, la scena performativa è molto meno elitaria di come viene descritta nelle accademie, più vicina a una serata di elettronica, o un’installazione. È molto più figa, insomma.
Se la performance è una forma di pensiero critico, quale può essere il ruolo della critica, ove non si voglia banalmente chiosare l’evento performativo e ove non si possa, ontologicamente, lasciarne traccia?

Dal mio punto di vista, che vuole restare esterno alla critica, perché già mi muovo tra il campo del pensiero e quello della pratica artistica, è necessario provocare un approccio realmente transdisciplinare, che non incroci solo gli oggetti d’indagine ma le epistemologie, cioè i modi con cui si pensa e si fa ricerca. Questo vale anche per oggetti del passato: si tratta di ricostruire le storiografie, riattivare gli archivi attraverso un’epistemologia viva – penso a ciò che InCommon, gruppo di ricerca sulle sperimentazioni italiane degli anni ‘60 e ’70, sta facendo a IUAV. La critica a me sembra innanzi tutto una questione di posizionamento. Dove ci si colloca rispetto all’artista che sta scrivendo/componendo per la scena? Il posizionamento viene prima del giudizio, cosa che è stata ampiamente acquisita dal secondo Novecento: l’idea di oggettività data dalla distanza, la separazione dall’oggetto, non è garanzia di scientificità, a favore invece dei saperi coinvolti e situati che proprio nel femminismo, da Donna Haraway in giù, sono fioriti. Non esiste alcun punto di vista kantianamente esterno. La funzione della critica è dunque di mettersi dentro, in un’interlocuzione coinvolta, mescolata, con la scena, perché non c’è mai un pensiero che si pensa da sé, da fuori, di pensare insieme (com-pensarsi, mi viene da dire) ad artiste e artisti. Mischiarsi, buttarsi nella mischia. Anche interrogando i propri spazi e propri dispositivi di produzione culturale, e facendone un campo di trasformazione e di innovazione.
Se la performance è una “teoria dell’agire”, allora un incontro, un libro, una piazza sono spazi performativi? Oppure ha ancora senso progettare spazi specifici per la performance?
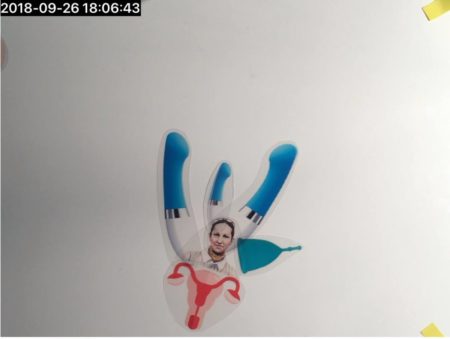
Se per spazi specifici intendiamo le sale teatrali, la rottura delle pareti è già nei nostri vocabolari dagli anni ’70. Tuttavia a mio avviso sì, la ricerca performativa ha bisogno di spazialità e temporalità precise, e penso che questa funzione sia stata operata, in Italia, principalmente dai festival – che pure sono sempre meno e meno finanziati, e costretti a svolgere funzioni di sussidiarietà. All’opposto, i Teatri Stabili sono ormai sempre più vittime dei propri vincoli strutturali, di sbigliettamento, di gestione delle proprie macrostrutture amministrative ancor più cristallizzate dopo la riforma Franceschini – per non parlare del problema delle direzioni, considerati i sette direttori maschi su sette Teatri Nazionali. E non è una questione di cosa abbiamo nelle mutande, ma di un pensiero trasformativo, dell’invenzione di nuovi modelli e prototipi. C’è un vuoto, abissale, pauroso: manca tutto quello che potrebbe stare in mezzo fra questi due poli e garantire la vitalità della ricerca, della formazione permanente, delle sperimentazioni che intercettano e creano nuovi pubblici. C’è mancanza di biodiversità istituzionale in Italia, di spazi informali, intermedi e indipendenti che siano in-between tra le cattedrali dei Teatri stabili e gli spazi autonomi, che vivono solo di autorganizzazione, continuamente esposti e messi in difficoltà. Penso all’occupazione del Valle, di cui ho fatto parte e che ha definito profondamente il mio percorso, ma che per certi versi non si è sedimentata in un’esperienza riconoscibile e strutturata, ma anche a luoghi come il Rialto o l’Angelo Mai, che invece di essere sostenuti sono invece consapevolmente messi in difficoltà. Certo, in ottica neomaterialista la fine non è mai una cesura, come vorrebbe la storiografia patriarcale: vi sono germinazioni sottotraccia che continuano a generare e a nutrire nuove esperienze. Se l’ondata di occupazioni e creazione di spazi culturali negli anni ‘10 è un unicum in Europa, quell’ondata rischia di non lasciare tracce se esposta a continua repressione e cancellazione, se le istituzioni esistenti non si lasciano modificare. Non dovrebbero fare molto, davvero, solo ascoltare – noi siamo piene di idee, le abbiamo messe in atto, descritte, raccontate. Pensiamo alle politiche di investimento in luoghi della cultura in Italia: quale è stato l’ultimo progetto di architettura pubblica per le arti a vocazione multidisciplinare, dove si possa non solo fruire di una programmazione, ma studiare, incontrarci, sostare, perdere tempo? Spazialità vuol dire materialità: è nello spazio condiviso che i corpi confluiscono e noi abbiamo bisogno di prossimità. La performance è questo, ci costringe ad una politica del contatto e non solo dello sguardo.
La performance come pensiero del corpo. Alla luce delle attuali innovazioni tecnologiche e delle politiche legate agli spazi virtuali, immagini che nel futuro il corpo sarà ancora il soggetto della storia?

Ci sono in gioco diverse prospettive teoriche e immaginari sul futuro dei corpi – penso al postumano femminista, contrapposto a un’idea transumanista. Se in entrambi i casi si tratta di superare l’umanesimo, la prima è una prospettiva “incarnata”, la seconda postula un superamento del corpo rimediato dalle protesi tecnologiche e dall’intelligenza artificiale. Penso alle ricerche militari sulla robotica, tutte basate sull’addestramento delle macchine alla violenza, o alle privatizzazioni superomistiche alla Elon Musk. Questa prospettiva denota una deriva trascendentalista molto pericolosa, proprio perché separa nuovamente la materia pensante dal corpo. È una prospettiva totalitaria, fascista – niente può risarcire il corpo. Il corpo non è un semplice supporto, e penso all’esperienza di insegnamento di questi mesi: la distanza dei corpi, non solo docente/studenti, ma tra studenti ha prodotto un impoverimento nei processi di formazione e trasmissione. Ma se è vero che le nuove tecnologie permeano la quotidianità, è anche vero che proprio l’esperienza femminista ci insegna che esse non sono neutre ma neanche nemiche di per sé, possono essere hackerate, così come molte comunità usano i social come spazio di soggettivazioni e di presa di parola. Negli anni ’90 – prima che le corporation privatizzassero, sezionando con veri e propri recinti/enclosure e mettessero sotto controllo la rete – le comunità underground avevano immaginato e praticato il web come un terreno di appropriazione e liberazione, e anche di organizzazione politica. Prima viene il comune, come potenza sociale espressiva e capacità di autoregolazione – il capitale sa solo catturare e separare. Per questo oggi dobbiamo ripensare il mondo virtuale come terreno di lotta, di lotte di messa in comune di codici, spazi digitali, transizioni.
Andrea Zangari














