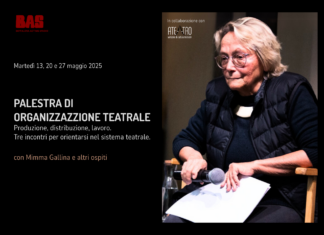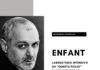Contemporaneo futuro nuove generazioni è il festival che da oggi fino al 25 luglio andrà in scena al Teatro India e Teatro Torlonia. Un tempo di approfondimento sull’infanzia di cui abbiamo discusso insieme al curatore Fabrizio Pallara di teatrodelleapparizioni

«Pensare al futuro rende il presente differente». Nella calma postprandiale di questo luglio affollato di festival, viaggi e ragionamenti, la telefonata pomeridiana con Fabrizio Pallara, regista, drammaturgo e fondatore del teatrodelleapparizioni, diventa occasione per «ragionare serissimamente» attorno alle forme e ai linguaggi che permettono di parlare alle nuove generazioni, e agli adulti che hanno accanto. La compagnia romana, giunta ai venti anni di carriera, presenta da oggi fino al 25 luglio il festival CONTEMPORANEO FUTURO nuove generazioni promosso, sostenuto e organizzato dal Teatro di Roma. Un fitto cartellone di eventi, tra teatro, film e incontri, abiterà gli spazi del Teatro India e Teatro Torlonia con spettacoli presentati al loro debutto e firmati da compagnie scelte per i loro percorsi e poetiche, coerenti alla prassi artistica e progettuale del teatrodelleapparizioni.
«Mi sembra un segnale importante che un teatro nazionale, nelle figure di Giorgio Barberio Corsetti e Francesca Corona, offra ospitalità a questo progetto. Siamo stati chiamati a continuare il nostro ragionamento sulla relazione scenica e questo ci fa sentire parte di un mosaico di artisti e idee», così ribadisce Pallara confermando quanto detto in una precedente conversazione, fatta alla fine del 2020, circa l’importanza di interlocuzione con le istituzioni cittadine.

Una dimensione esperienziale lunga quattro giornate si apre, attraverso la multidisciplinarietà, a una relazione multipla: «non lo definirei solo teatro ragazzi, non sarebbe esaustivo, è piuttosto un completamento della visione. Il bambino può andare a teatro solo con l’adulto, e l’adulto che va a teatro col bambino è uno spettatore speciale, perché vive dell’emozione della relazione che permette di far risuonare insieme le rispettive sensibilità». Per tali ragioni, a questa programmazione si aggiungono anche due necessari momenti di approfondimento a ingresso gratuito dal titolo Teatro e Altrove che saranno curati da Roberta Ortolano, docente di lingua e letteratura italiana e latina al liceo, specializzata al sostegno didattico. Infanzia: una storia infinita e L’arte della ricreazione saranno due tempi distinti per «condividere un’idea collettiva di infanzia» e, a partire dagli spettacoli, «una discussione sul linguaggio teatrale, sui temi, sulle tecniche espressive e le poetiche come stimoli esperienziali e veicoli di conoscenza».

L’azione portata avanti in questi anni dal teatrodelleapparizioni – insieme a Pallara, Sara Ferrazzoli, Sara Ferrari e Valerio Malorni – si contraddistingue per una precipua spinta ad andare oltre le categorie di fruzione e, di conseguenza, distribuzione. Verso una prospettiva di autonomia e emancipazione dalle burocratiche lungaggini scolastiche, gli spettacoli dedicati alle nuove generazioni dovrebbero infatti trovare una maggiore attenzione per le riflessioni e stimoli che sono in grado di suscitare. Anche e soprattutto per un occhio “critico”. «Recentemente ho visto il film di Claudio Cupellini, La terra dei figli; credo siamo stati finora troppo impegnati a occuparci del nostro presente, con la velleità di poterlo controllare, di imporci su di esso. Dovremmo tornare a ragionare sul ruolo di accompagnamento verso il futuro invece, e non di guida, dei padri verso i figli. I bambini non sono ingenui, sono spontanei, rappresentano l’essere umano per quello che è: l’uomo, senza addomesticazione – ha continuato Pallara. Non un teatro ragazzi quindi ma un teatro «per la cultura dell’infanzia, il cui impegno è arduo: cosa insegnare attraverso di esso, cosa dire? Educare, innanzitutto, che vuol dire “condurre”, ma condurre dove, verso cosa?».

Per il teatrodelleapparizioni il rapporto con la cittadinanza è dunque una relazione fondamentale, nutrimento indispensabile assimilato grazie a una processualità fatta di incontri e incursioni in spazi altri, all’interno della città di Roma e nei suoi luoghi teatrali. Dopo la rassegna Domeniche Indiane programmata lo scorso anno e poi sospesa per l’emergenza sanitaria, nata dalla curatela estesa anche ad altri artisti e collaboratori attraverso la quale veniva creato uno spazio pubblico in cui le famiglie, e non solo, potevano mescolarsi e conoscersi; è stata la volta, a inizio estate 2021, tra maggio e giugno, della rassegna “fiabesca e desituata” Fiabe altrove, coordinata sempre da Fabrizio Pallara, con Valerio Malorni e le musiche dal vivo di Federico Ferrandina. Una stagione estiva pensata all’aperto per poter mettere il pubblico nella condizione di stare più tranquillo nel rispetto delle norme sanitarie e per abitare in maniera insolita gli spazi del Teatro Torlonia. Sono state raccontate le fiabe di Cenerentola, Raperonzolo, La bella addormentata nel bosco e Biancaneve Altrove, la cui traduzione di Antonio Gramsci ha incontrato la polifonia musicale di Ferrandina e quella luminosa firmata da Camilla Chiozza e Marco Guarrera di Malombra. La poesia netta e realista del testo gramsciano si addensa e espande sulle vetrate dell’ingresso alla serra dei Torlonia: una composizione per macchie d’ombra fuse a cromatismi visivi, sensibile la simbologia usata, coinvolgenti i nessi semantici con la parola ascoltata e incisa dalla voce, sempre devota al rinnovato incanto, di Malorni. Il bisogno universale, e ancestrale, di farsi raccontare una storia emerge sin dall’inizio, appena seduti nel buio della villa, quando di sera fanno la loro comparsa i primi pipistrelli attornianti la fontana centrale. Stiamo lì, insieme e in silenzio, ad ascoltare il testo privo di rime e della volontà di edulcorare le parole, dalla concreta crudezza nell’utilizzo dei termini scelti e determinante un’attenzione seriosa negli astanti, sia bambini che adulti, mentre la meraviglia della poesia di luci, ombre e suono si schiude come sinestesia di forme e linguaggi. M., seduto accanto a me e vicino alla sua amica A., è concentrato coi piedi penzoloni e scalpitanti in contemplativo silenzio, fino a quando però, davanti alla fiducia di Biancaneve nella strega cattiva che la consegna più volte alla morte apparente, dirà infastidito: «ma perché continua ad aprire la porta? Mamma, perché apre la porta alla matrigna?”. Ha ragione M., perché Biancaneve, giovane, buona e bella, deve aprire, più di una volta, la porta alla strega brutta vecchia e cattiva?

Biancaneve, nella sua forza, bellezza e propositiva giovinezza, è allora un ostacolo rispetto a un passato non più attuale, vecchio e quindi fermo, invalidante per le nuove generazioni, che le inganna e poi avvelena. L’adulto, di fronte la domanda di M., non solo ne coglie la critica energica e sollecitata nel bambino dall’interesse per il racconto, ma grazie all’interrogativo inatteso può ricontestualizzare l’esperienza sovrastrutturata della visione e smussarne l’attitudine conservatrice di rispetto, che soffre della nostalgia per quella forza ineducata di questione e inversione di senso. La riflessione nasce così in un momento di svago, durante una serata a teatro con mamma e papà e poco prima di andare a mangiare la pizza. La cultura dell’infanzia, per adulti e bambini, è questa essenziale spontaneità. La domanda di M. è politica, e lui è già un ometto politico. Che sia allora un presente carico di futuro!
Lucia Medri