Nel T.RAUM con Antonio Viganò dopo aver assistito alle prove dello spettacolo Bianca e Neve. Intervista
Fondatore della compagnia Teatro La Ribalta con la quale vince il premio UBU nel 2018 per la qualità della ricerca artistica, creativa e politica in ambiti spesso marginali e con attenzione capillare alla diversità, Antonio Viganò ci apre uno scorcio sulla sua poetica e la sua estetica.
Qual è il contesto storico artistico nel quale hai iniziato a fare teatro?

Teatralmente vengo dagli anni settanta e ottanta, da Grotowsky, dal momento nel quale il concetto di spazio teatrale si modificava, il teatro di strada portava altre spinte, il teatro usciva dalle cattedrali. Per la mia formazione come attore ho frequentato la scuola del Piccolo Teatro di Milano e poi l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Ma della spinta di quegli anni mi rimane soprattutto la ragione politica; il teatro era vissuto come trasformazione dei contesti sociali, pensavamo di poter cambiare il mondo. Nascevano così i gruppi di base; noi eravamo in un paesino, non sapevamo come fare, e da lì ho detto “proviamo a fare teatro” e in una cantina Arci è nato un gruppo, come concezione molto vicino ai Magazzini criminali. Io ero già consigliere comunale in politica, in quegli anni lì la tensione politica era dominante, non si parlava di estetica. Nel teatro ci sentivamo tutti vicini, parenti della stessa famiglia – di Danio Manfredini, di César Brie – l’etica della battaglia politica ci teneva molto uniti. Finche poi tutto è passato all’estetica, allora tutto si è scomposto.
Quando hai iniziato ad avvicinarti al tema della diversità e del disagio?
Fratelli è stato lo spettacolo che mi ha avvicinato al tema della diversità, della comunicazione nell’autismo. È stato uno spettacolo che ci ha fatto girare tutta l’Europa; eravamo a Lille quando sono venuti L’Oiseau Mouche – la prima compagnia teatrale Europea costituita da uomini e donne in situazione di handicap – a vederci; dopo averci visto mi hanno chiesto se volevo lavorare con loro, sono stato regista della compagnia per cinque anni. Intanto come Teatro La Ribalta con Scadenze avevamo iniziato una collaborazione con Caterina Sagna, e poi con Julie Anne Stanzak che è stata dal ‘92 fino all’anno scorso, a fasi alterne, la nostra coreografa. Poi, quando La Ribalta come l’avevamo immaginata – io e Michele Fiocchi eravamo una coppia molto forte – è finita, ci siamo divisi. Io sono rimasto un po’ a Lille, ho fatto altre tre produzioni con L’Oiseau mouche e poi quando sono tornato in Italia sono venuto a Bolzano per amore. Qui, forse grazie a una certa laicità che c’è sul tema, ho iniziato con i laboratori in situazioni di disagio; dopo che Bolzano Danza ha iniziato a produrmi alcuni spettacoli, abbiamo fatto questa scommessa di dare una struttura a questa realtà, di trasformare quei laboratori in una compagnia professionale: abbiamo quindi fatto nascere l’Accademia Arte della Diversità nella quale oggi lavorano undici attori e attrici in situazioni di disagio, con contratti, contributi, tredicesima e due operatori. In cinque anni c’è stata una grande crescita, il premio Associazione Nazionale dei Critici nel 2017 e il premio UBU nel 2018. In cinque anni siamo passati da venti repliche annue a novanta. Grazie a un fondo sociale europeo abbiamo professionalizzato i nostri attori, la direzione per la formazione e l’attività laboratoriale è affidata a Paola Guerra.
Qual è la tua modalità di lavoro? Cosa cerchi in scena?

Mi piacevano quei corpi perché sono corpi poetici, fortemente narrativi. Io credo molto che in ogni gesto del nostro corpo ci sia la nostra storia. Come dice benissimo Galimberti, nel nostro modo di offrirci al mondo c’è il nostro passato, presente e futuro. Un attraversamento di una scena di uno dei nostri attori gli richiede una concentrazione, un certo tipo di tensione muscolare che può diventare racconto. Perché non è come se lo facessi io. Io casomai devo stare attento alla mia postura, ma nella loro postura c’è anche la maschera sociale che portano.
Durante le prove oggi hai detto “i corpi dovete abitarli”
È importante che gli attori siano sempre credibili. Ma loro solitamente lo sono, sono meno sovrastrutturati di me, sono totalmente in quello che fanno, e questa è la loro ricchezza. Ovviamente non è una garanzia di qualità, ma se tu la sai cogliere è un potenziale enorme. E allo stesso tempo, e questo è essenziale per il teatro, hanno delle ombre profonde che sono dovute alla loro condizione. E quelle ombre profonde, che sono anche il mistero di quelle vite, hanno un fascino straordinario in scena; questo però, solo quando quegli attori riescono ad andare oltre la condizione per farla diventare comunicazione, e non rimanere bloccati nella mera “condizione”. Usare quella condizione come veicolo per portare lo spettatore a fare un viaggio altrove, senza continuamente inchiodarlo al “guarda, sono invalido”, ma passando oltre grazie alla capacità di attori, di stare in scena. Allora si, il viaggio è molto bello.
Un episodio scenico che hai visto che ti ha fatto prendere una posizione sul lavoro che stai portando avanti?

Mi ha segnato uno spettacolo che ho visto a Bari. Enzo Toma, I segni dell’anima. Ci sono tre cose che mi hanno segnato, e riguardavano lo sguardo del pubblico: la prima è che l’applauso più caldo è stato fatto al ragazzo down che cantava così bene che poteva essere un ragazzo ‘normale’. Mi sembrava che con quell’applauso lo premiassero perché era diventato simile a noi, nonostante il suo handicap. Perché invece nello stesso spettacolo il momento più emozionante per me non era quello, ma quello durante il quale una ragazza tetraplegica faceva una coreografia che a me ricordava Pina Bausch. Nonostante la contrazione dovuta al suo stato. Dal mio pensiero al mio gesto c’è una frazione di tempo che lo modifica, e nella danza l’impulso che tu dai non è detto che corrisponda al risultato, soprattutto per quella ragazza. Ma questa attrice era talmente brava che sapeva quale sarebbe stata la restituzione del suo gesto per cui non ne tentava un altro ma cercava di fare di quella restituzione, di quella tensione che lei conosceva, la coreografia. Per cui non c’era una lotta tra ciò che voleva fare e l’impulso muscolare che glielo impediva; aveva una conoscenza così completa del suo corpo che riusciva a far diventare quella contrazione una coreografia. La terza cosa che mi ha segnato, che era una genialità – bisognava vedere però lo spettacolo tre volte per coglierla – era che a un certo punto dopo una scena di caos, rimaneva un attore da solo in scena. Quell’attore restituiva l’idea che si fosse perso, tutti erano usciti e lui era rimasto li come un baccalà, guardava il pubblico con un sorriso disarmante, e c’era un operatore che entrava e lo prendeva e diceva al pubblico «scusatelo». Questo però era voluto, perché la stessa cosa l’ho vista nelle repliche dopo. L’ho trovata una genialità. Tanto che il primo spettacolo di L’oiseau mouche l’ho chiamato Excusez-le proprio in omaggio a quel gesto lì, perché era semplicemente quello che il pubblico si aspettava.
Perché poi tutto questo lavoro qui è nella relazione che c’è con il pubblico. Tutto il discorso sulla credibilità, sulla condizione della comunicazione, l’idea se il pubblico esce trasformato, se c’è uno sguardo consolatorio, se davvero modifichiamo lo sguardo di chi viene e si aspetta una cosa e ne trova un’altra, o magari esce deluso. Ci piace tante volte andare alle rassegne e non far sapere prima che noi abbiamo delle disabilità.
Quale sguardo cerchi nel pubblico?
Il più neutro possibile. Se già siamo annunciati come la compagnia de diversi, la gente viene con delle lenti strane e noi facciamo più fatica a intervenire lì dentro, invece è più bello quando sono sorpresi se noi sappiamo stare sulla comunicazione e non quando rimaniamo impantanati nella nostra condizione. Uno può anche tentarci e non farcela, ma questo movimento deve appartenere a tutti.
Oggi Mathias, durante un esercizio, ha detto che non riusciva a dire la battuta come avrebbe voluto. Cosa deve riuscire a fare un attore invalido, la stessa cosa che potrebbe fare un attore non invalido?
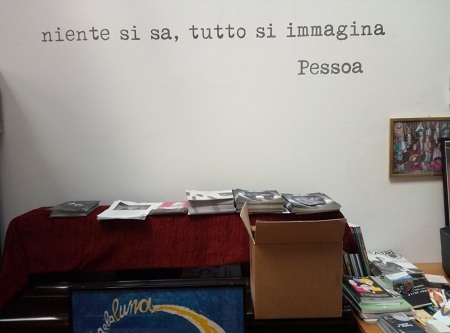
Questo è il tema della regia. Io mi domando spesso “cosa faccio, li ammaestro? Stanno diventando tanto bravi che sono diventati normali?”, “andiamo in giro e ci danno il premio UBU perché siamo tanto bravi perché ci avviciniamo al normale?” No. A me interessa invece quando con questo nostro vocabolario si riesce ad andare oltre. Se faccio un Otello con un balbuziente – come nel caso del nostro attore Rodrigo in Otello circus – non è che gli chiedo di non essere più balbuziente; non è Rodrigo che si deve normalizzare, è Otello che si adatta a Rodrigo. Il salto è drammaturgico: c’è un aspetto di Otello, sicuramente, che prende valore dentro un attore che è balbuziente con quelle stesse parole di Otello. Riverbera in un altro modo. Ma la stessa cosa lo fa qualsiasi altro teatro, qualsiasi attore rispetto alla sua fisicità per abitare dei personaggi.
Questa componente rende più funzionale il tuo lavoro, o è una complessità ulteriore da risolvere?
La scommessa rimane la stessa, riuscire a modificare qualcosa in qualcuno che viene a vedere. Io lo faccio con questi corpi, altri in altra maniera. Io ho quel materiale umano e mi piace che sia quello a scuotere o a porre delle domande a chi lo guarda. Poi anche noi possiamo fallire. Il punto è che se io, Antonio Viganò, faccio un bellissimo spettacolo da attore, sono un bravissimo attore. Se io faccio un bruttissimo spettacolo, sono un pessimo attore. Il problema invece della nostra compagnia risiede nella rappresentazione sociale dei nostri attori; se non sono bravi ritorna l’handicap, si rimanda alla condizione. Quando vedo la diversità che non sa riscattarsi in qualche modo, che la condizione rimane li e non si riesce a superarla, si fa un danno pesantissimo a quella persona. Lì c’è un senso etico che noi dobbiamo assumerci.
Perché hai deciso di lavorare con l’handicap?
Perché sono vite più interessanti, perché mi riguardano, riguardano le mie ferite personali, le contraddizioni. A volte hanno delle leggerezze straordinarie che invidio e altre volte voglio stare lontanissimo dalle loro ferite. Quei mondi vale la pena di rappresentarli. In quell’umanità lì troviamo conflitti nostri del passato, cosa eravamo o cosa potremmo essere, e cosa invece siamo oggi. E poi c’è la parte dell’ombra e del mistero; sono gli attori che proiettano ombra che sono interessanti, perché ti interrogano continuamente. Il concetto di bellezza oggi è un concetto levigato. Il piacere che si ha è un piacere del “mi piace”. Ma la bellezza è un’altra cosa, è quella dove dentro c’è una ferita. La bellezza è quella ferita che ti interroga. Questo tempo ci chiede di mettere un mi piace, ma non ti trasforma, non ti lascia vedere un’altra possibilità.
Qual è la storia del vostro spazio, il T.RAUM, luogo nel quale abita la compagnia? Cosa significa?

Quando abbiamo fatto casa è cambiata la nostra vita. Bisogna fare casa, bisogna avere un luogo. Avere una casa e un luogo ti cambia, perché ti posiziona finalmente. Farsi luogo. Avere un luogo che appartiene a chi lo abita, ed è casa tua dove poi puoi aprire la porta e ospitare e fare venire qualcuno. Quello spazio lì lo abbiamo aperto da 5 anni, e sembra che siamo lì da venti per quanto è usato. È riconoscibile. Tutti i giorni lo abitiamo in tredici, due operatrici io e Paola e gli attori. Poi riusciamo a fare tanta formazione grazie al fondo sociale europeo e a risorse nostre, invitiamo molti artisti che stimiamo per formarci. Il nome T.raum lo abbiamo scelto insieme ai ragazzi; viene da due parole tedesche, traum, sogno, e raum, spazio.
ll premio UBU nel 2018. Che rapporto hai con questo premio?
Sono stato molto contento. La motivazione mi piaceva, perché coglieva allo stesso tempo un aspetto politico e di qualità artistica. Avrei preferito vincerlo su uno spettacolo rispetto al vincerlo sulle nostre intenzioni di essere a tutti gli effetti una compagnia come le altre. C è chi dice che comunque è dovuto all’Otello, che ci ha fatto conoscere ai giurati. Finalmente il teatro scopre che ha dentro un corpo che gli appartiene, quello nostro, quello di Chiara Bersani, di Berardi/Casolari. Alla premiazione ho detto “finalmente mi sembra di essere parte del teatro e non un teatro a parte”.
Il 12 e 13 ottobre organizzerete qui a Bolzano il seminario di studi La malattia che cura il teatro.
È un ossimoro. . Ha bisogno della malattia, della ferita, del segno. Ce lo diceva Artaud, ce lo dicono le grandi opere. Il teatro ha bisogno di ritrovare il suo ruolo di un corpo che sanguina, non che dia sollievo. Deve sanguinare, mettere le dita profondamente nelle nostre ferite, se vogliamo davvero essere in narratori del nostro tempo. Altrimenti rischiamo di creare un’estetica che diventa sonnifero. Dobbiamo riscoprire il senso della ferita. Dobbiamo sempre salvaguardare la nostra vulnerabilità. L’umano esiste perché è vulnerabile, se non lo fosse sarebbe un automa.
Nel tuo lavoro, però, allo stesso tempo, c’è anche un estetica che funziona molto.
Si, l’estetica è il veicolo del messaggio. Più è chiara e meglio riesco a raccontare. Io non ho mai scelto se fare il teatro o fare la danza, per cui ogni tanto mi trovo li in mezzo a questo conflitto. Lo risolvo lavorando sull’attore. Io penso al teatro come un arte vicino alla scultura, non ho davanti dei corpi neutri ma delle pietre da scolpire, con dei tagli, delle forme, un peso e una prospettiva che è già un racconto. È l’arte del togliere, devi riuscire a entrare dentro quel sasso per trovarne una forma. È il dibattito del teatro degli esseri e del teatro di rappresentazione, che dice che tutto il teatro che dialoga con il sociale in situazioni di emarginazione, periferiche, o di disagio fisico e mentale, è il teatro degli esseri. La loro condizione è parte del racconto, anche se non è centrale. Dall’altra parte il teatro della rappresentazione deve invece aggiungere. Io cerco di togliere, se no c’è una bulimia di segni dalla quale non riesci a uscire.
Qual è la parte più difficile di questo lavoro?
La lotta difficile è quella della consapevolezza. Perché questi attori ci fanno dei regali molto intimi. Li dobbiamo usare con molta delicatezza. E quando gli si da loro la consapevolezza che in quel momento in scena stanno facendo ridere o stanno commuovendo, non malgrado loro, ma perché loro come attori stanno toccando quelle corde, ecco secondo me questo è il lavoro più bello che faccio. Se ce la faccio.
A volte mi dicono “intervistiamo i tuoi attori”, ma io so che quello non è la loro linguaggio, non è il loro strumento. Hanno per esempio una memoria del corpo più forte della mia e di molti altri, di questo ne sono certo, solo che non sono in grado di restituirlo attraverso il l’intervista. Io allora dico «se volete, fategli delle domande», e a volte gli attori non fanno una gran figura rispondendo. Però, comunque, poi nessuno glielo dice, anzi partono dei grandi applausi consolatori. Sai quegli applausi di incoraggiamento, che è anche un applauso generoso. A me fa sorridere, ma dall’altro mi ferisce perché so che chi lo fa mette una distanza. Una distanza profonda. È un applauso che rischiamo anche in scena se non siamo bravi, se non facciamo una drammaturgia che non da spazio alle pause dell’applauso; se partono gli applausi in mezzo allo spettacolo, ci rendiamo conto che non siamo andati lì dove volevamo andare. Per noi l’applauso, quando è dentro, ci rivela un errore, non una bravura. È strano perché è l’opposto. Ma ci rivela che stiamo sbagliando, che non siamo riusciti ad andare oltre. Stanno applaudendo a quella condizione, a quel tentativo, non siamo riusciti a portarli fuori da lì.
Luca Lòtano
Leggi anche: Il teatro sociale e la trappola del dilettantismo










[…] (Antonio Viganò in: Luca Lòtano, “‘‘Se il teatro non è un po’ malato, rischia di morire’. Intervista ad Antonio Viganò”, in: Teatro e Critica (3.10.2019), https://www.teatroecritica.net/2019/10/se-il-teatro-non-e-un-po-malato-rischia-di-morire-intervista-… […]