
Cominciamo con una confessione. Ci piacerebbe tanto, da giornalisti, mettere in testa a un articolo una frase del tipo: «Questo è un momento storico». E la presentazione, dopo 27 mesi di occupazione del Teatro Valle, della ormai attesissima Fondazione Teatro Valle Bene Comune, poteva essere l’evento candidato a meritarsi un simile incipit. E invece no. Tra le personalità invitate a sedere sulle sedie (di velluto pure quelle) ai piedi del palcoscenico c’era Stefano Rodotà, una figura di spicco della società civile degli ultimi cinquant’anni. È proprio lui, nel discorso che – dopo una breve e timida ouverture musicale di violoncello e chitarra – apre la giornata, a frenarsi la lingua un attimo prima di pronunciare la fatidica frase. Si corregge poi, con mirabile ironia: «Ultimamente soprattutto la parola “storico” l’abbiamo sentita troppo spesso, teniamoci lontani da queste retoriche». Ottimo consiglio.
In una convocazione che ha riempito platea e palchi dell’antico teatro, mescolando i toni della conferenza stampa con quelli della più appassionata dichiarazione di vittoria, è stato dunque annunciato il deposito presso il notaio dell’Atto costitutivo della Fondazione, dedicata a Fabrizio Fontana e a Nicola Rondolino, che ha conquistato anche un premio della European Cultural Foundation e vanta un «vero e proprio patrimonio – ha spiegato una occupante nel discorso introduttivo – di azionariato e knowhow artistico, culturale, sociale e politico». Si parla di uno «statuto come strumento vivo dell’unione di artisti e cittadini nel processo costituente», si parla della «necessità di prendersi cura e di preservare questo posto», si anticipano questioni come «decisione partecipata» e «turnarietà delle cariche», all’interno di un regolamento che, allo stato attuale, non è stato ancora reso pubblico nei materiali consegnati alla «prima assemblea» della Fondazione, che si sarà tenuta di fatto proprio il 18 settembre 2013, a qualche mese dalla ratifica ufficiale del Prefetto.
Il fatto empirico lo centra proprio il discorso di Rodotà: l’evidenza, da ora in avanti, che l’occupazione di spazio pubblico datata 14 giugno 2011 non è più rappresentata da «una comunità informe», ma ha dato vita a «un soggetto nuovo, che ha diritto e modo di dialogare con altre istituzioni. Da ora in poi le mura di questo edificio e la sua gestione riguardano l’interazione con gli altri enti locali che partecipano. Sono quelle istituzioni a non poter più prescindere dalla sua reale esistenza, alla pari». Rodotà poi tenta un azzardato parallelo con altre celebri lotte, del passato o del presente, da quelle per i diritti dei lavoratori al referendum per l’acqua pubblica: qualsiasi battaglia combattuta dal basso «deve sempre trovare approdo nella istituzionalizzazione, un elemento per fondare quello che era già stato fatto e per rafforzare l’azione successiva». E però questo cambio di marcia, avverte lo stesso giurista, è che con questo nuovo ruolo crescono le responsabilità, che devono «allontanare dall’autoreferenzialità e dall’autocelebrazione: quello appena creato è un modello, non certo l’unico».
Non sono mancate le parole affettate di chi l’esperienza Valle l’ha seguita da vicino, come l’attore e regista Fabrizio Gifuni, che ha ripercorso la storia dell’occupazione – «uno degli eventi più importanti significativi e belli, per tornare a considerare il teatro un simbolo di qualcosa che si deve riattivare, combattendo contro la logica del piagnisteo, anche in un momento di vuoto di rappresentanza» – ribadendo poi l’invito di Rodotà a rivendicare un punto di svolta, «ora che sono caduti gli alibi e serve un confronto serio».
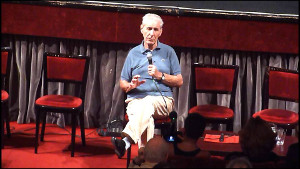
Sembra insomma che la certezza di tutti sia che il deposito presso il notaio di questo «modello possibile» sia sufficiente a destare l’attenzione delle istituzioni, sotto forma, spiegava l’occupante Ilenia Caleo, di «un percorso pubblico che non si riduca a una trattativa, un processo politico che coinvolga tutta la città per immaginare nuove forme in maniera partecipata». E tuttavia i termini pratici di una interlocuzione – dei quali una domanda del giornalista e critico Antonio Audino chiedeva conto ma che sono forse precoci da immaginare – non sono ancora definiti, comunque non ancora chiariti. Così come altri punti fondamentali quali le forme di finanziamento e il tipo di relazione che legherà la Fondazione Teatro Valle Bene Comune ai flussi di denaro e risorse in entrata. Nello Statuto si legge: «La Fondazione lavora, crea, gode secondo il modello della cooperazione, dell’autogestione, della condivisione di risorse e vita. Questo modello si finanzia attraverso fonti che non si limitano a quanto volontariamente viene donato dai suoi sostenitori, né a ciò che derivi dalle attività dirette della Fondazione nei suoi rapporti economici con terzi, o dalla partecipazione ai bandi». E ancora, si parla di una «lotta per il riconoscimento di necessarie risorse pubbliche e forme di finanziamento diretto da parte dello Stato» e per la ricerca di principi come «solidarietà, non-discriminazione, promozione dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, tutela ambientale», da ricercare anche nei «rapporti economici con terzi, quali, a titolo di esempio e in modo non esaustivo, gli sponsor, le donazioni, i fornitori di beni e servizi». Questo è e sarà sempre il punto più delicato: sul piano pubblico si affaccia la contraddizione che vede i donatori (finora e d’ora in poi) come una strana creatura di “doppi contribuenti”, dal momento che le tasse di per sé dovrebbero consentire l’accesso alle risorse culturali reclamate qui. E su questo punto sono le istituzioni che dovrebbero riflettere, prendendo atto di un movimento popolare appassionato che vale almeno 150mila euro. E però, chiederemmo al Valle: come sostenere un organo che si basa sull’azione partecipata, sulla democrazia diretta se – com’è giusto e necessario – alle logiche di sistema dovrà comunque rispondere, proprio adesso che a quel sistema ufficialmente appartiene?
Partecipare a bandi pubblici o accettare (di conseguenza auspicare) un sostegno da sponsor privati o fornitori pone di certo la Fondazione di fronte al rischio di quel (rifiutato) «modello economico e sociale con logica di competizione individualistica», su cui anche i rapporti economici più trasparenti necessariamente si basano. A vigilare sulla virtuosità di queste forme di finanziamento sarà, stando allo Statuto, un apposito Regolamento, fondato «sulla tutela e la promozione dei principi» dichiarati. Tale Regolamento, tuttavia, non è stato ancora presentato in forma ufficiale e dovrà fare i conti anche con altri strumenti di partecipazione diretta e di «democrazia reale» come la turnarietà delle cariche, l’autogoverno incarnato nell’assemblea, la pratica del consenso e il superamento del principio di delega, la creazione di una comunità che non sia più solo «gruppo o collettivo» – come forse finora è stata o è stata vista – ma come «attuatrice dell’esperienza di un processo aperto e condiviso».
Secondo Fausto Paravidino – dopo lunghi mesi alla conduzione dell’approfondito ciclo di studi e laboratori di drammaturgia Crisi. Il macello di Giobbe, firmerà lui il testo della prima vera produzione della Fondazione Teatro Valle Bene Comune, coinvolgendo «decine di artisti, maestranze e operatori» – la specialità del teatro «è la partecipazione, la costruzione di comunità attorno a una storia. Cosa non molto popolare ora che il neoliberismo promuove proprio l’individualismo». Il drammaturgo ha poi rimarcato come il mondo di oggi tenda a «misurare tutto attraverso i numeri». Scriveva anche Massimo Marino parlando dei festival sui Quaderni del Teatro di Roma: «La cultura non è una variante dell’economia. Non è vero che va coltivata perché porta lavoro e fondi. La cultura va sostenuta perché cambia l’essere umano. In modi imprevisti, invisibili». «Siamo ormai costretti a chiederci continuamente il senso di quello che facciamo con il teatro – continuava Paravidino – e i direttori dei teatri non occupati fanno i conti con questo, fanno molta fatica a fare ricerca a fare esperimenti, perché se la somma non dà un grosso numeretto verranno bocciati. Quindi stiamo cercando di fare quello che altri non possono?».

Ecco sfiorato un altro nervo, quello che nei mesi passati, soprattutto da quando sono diventati così tanti, ha fatto sobbalzare alcuni “direttori di teatri non occupati”, alle prese con mutui da pagare e agibilità da emettere. Da una giornalista de La Repubblica arriva presto la domanda diretta, che fa riferimento a un articolo de Il Messaggero in cui gli occupanti del Valle (tutt’ora tali, nonostante la neonata Fondazione) venivano messi al pari di altri «abusivi», come comunità rom e mercati stradali. Insomma, in un modo o nell’altro la risposta alla domanda di Paravidino è di certo affermativa, è un fatto che al Valle sia stato permesso quello che ad altre realtà omologhe (numerosi gli spazi teatrali o para-teatrali chiusi negli ultimi anni) è stato negato. Si parla ovviamente delle questioni più mere, che forse esulano dagli entusiasmi di un progetto culturale che sembra ora sulla punta del trampolino, ma che costituiscono proprio quei numeri contro cui, a parole e a Statuto, si vorrebbe insorgere: affitti, utenze, importi Enpals e SIAE, misure di sicurezza e manutenzione. Combattere è una cosa, evitare un’altra. Risponde, in parte, Caleo, non disturbata dall’essere associata ai rom e al loro tipo di innesto sul territorio e che specifica come scopo dell’occupazione non fosse «avere un posto in assegnazione o giungere a una trattativa di risoluzione. Qui si misura la capacità delle istituzioni di recepire, si tenta di immaginare un altro modello oltre la trattativa, andando oltre la canonica polarizzazione tra legalità e illegalità. Violare leggi ingiuste – conclude poi – è un punto di avanzamento rispetto alla crescita di una comunità».
La cosa che stupisce è come alcuni degli speaker guardino al Valle come alla prospettiva di un teatro diverso «da ogni altro teatro della città» (Gifuni), come se un’alternativa alle poltrone di velluto e alle signore impellicciate non esistesse, come se questa città non brulicasse già (e forse mai come adesso) di esperienze indipendenti che in spazi privati tentano di ricostruire un’idea artistica ma non solo, anche di restaurare un’urgenza culturale usando non solo le armi di cartelloni di alto livello di ricerca, ma anche attraverso formazione, lavoro su e con il pubblico, lobby virtuose. E forse è anche con strutture come queste che una Fondazione nata sul territorio potrebbe o dovrebbe entrare in contatto, fare rete al di là di quella competizione rifiutata e verso una generale competitività. Rodotà e Gifuni parlavano di «esperienze diverse e disperse che hanno trovato il modo di lavorare insieme», di un «teatro che non viva uno spazio limitato della giornata ma abbia mille possibilità, che rispondano a una molteplicità di richieste espresse o inespresse dalla società». E se quel bene comune esistesse già e fosse da tempo in cerca di una modalità lineare e legale per mettersi in evidenza?
Sergio Lo Gatto
Leggi lo Statuto della Fondazione
Leggi la Vocazione della Fondazione Teatro Valle Bene Comune











